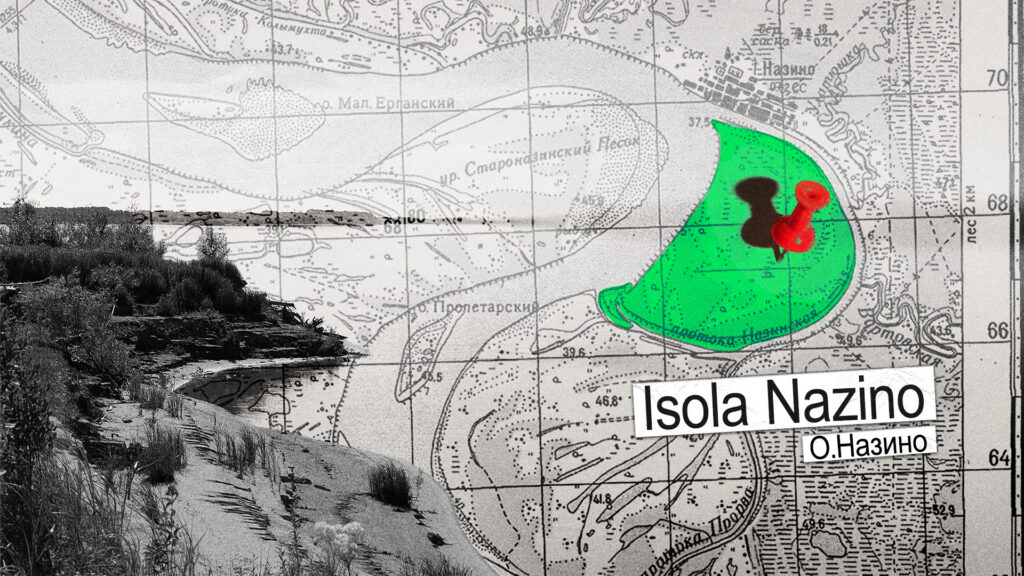Fabio Deotto
Contro il fatalismo climatico

17 Ottobre 2023
Se non è vero che il tempo per arginare la crisi climatica è scaduto, perché il disfattismo contagia anche attivisti e ricercatori autorevoli? Il problema è, almeno in parte, evolutivo: dobbiamo allenare il nostro cervello a immaginare un cambiamento positivo.
La mattina dell’8 dicembre 1973 la giapponese Toyokawa Shinkin Bank era tutto fuorché una banca a rischio. I suoi clienti ci si affidavano senza timori e la sua solidità era data per scontata dalle istituzioni. Meno di sette giorni dopo la situazione si era ribaltata: la maggior parte dei correntisti aveva prelevato i propri risparmi, si vociferava che il direttore avesse tentato il suicidio, la banca era a un passo dal fallimento.
In quella settimana non era successo nulla di rilevante. Non c’erano state flessioni dei mercati finanziari, la banca non era stata coinvolta in nessuno scandalo, la sua attività non era cambiata di una virgola. Era però successo che tre studentesse di liceo avevano chiacchierato sulla carrozza di un treno regionale.
È l’ultimo inverno prima del diploma, Sakura, Riko e Himari tornano a casa dopo una giornata di lezioni, le loro discussioni orbitano attorno agli esami di fine corso e a quello che succederà dopo il diploma. Sakura racconta che sta facendo un praticantato alla Shinkin Bank ed è probabile che già da quell’estate comincerà a lavorare lì in pianta stabile. Le altre due decidono di provocarla un po’: “Un lavoro in banca? Ma non lo sai che la banca è pericolosa?”. Si riferiscono alla possibilità che l’istituto venga rapinato. Ma questo Sakura lo tralascia quando torna a casa e chiede ai genitori “è vero che la Toyokawa Shinkin Bank è pericolosa?”.
La domanda innesca una reazione a catena, che ha le dinamiche di un telefono senza fili, ma anche di un’epidemia: i genitori di Sakura sottopongono la questione ad alcuni conoscenti, che a loro volta la estendono a un raggio più ampio di persone; di lì a pochi giorni la gente ne parla dal parrucchiere, alle poste, negli spogliatoi delle palestre. Passando di bocca in bocca la curiosità assume contorni più definiti, guadagna dettagli, infine si fa notizia. Il punto non è più se la banca sia o meno pericolosa, ma se chi ci ha depositato i risparmi non faccia meglio a prelevarli prima che sia troppo tardi. Il tracollo è quasi immediato: in meno di 48 ore 5000 risparmiatori attingono ai propri conti svuotando le casse della banca di 2 miliardi di yen. L’istituto di credito ora rischia davvero la bancarotta.
La storia che avete appena letto non è un esempio isolato. Si tratta di un fenomeno noto come “panico bancario”, un tipo di profezia autoavverante che ha spesso contrassegnato le crisi economiche dal XVI secolo ad oggi. Il caso della Toyokawa Shinkin Bank però è unico, perché venne generato esclusivamente dalle false aspettative di una comunità. Per questo si presta bene a inquadrare una distorsione cognitiva che contamina il nostro sguardo da sempre, ma che in tempi di crisi climatica risulta ancora più pericolosa: oggi, infatti, la profezia che rischia di autoavverarsi ha una portata molto più trasversale e devastante di una semplice bancarotta.
1. Una sfida troppo grande per una sola mente
Scrivo queste parole nei primi giorni di un ottobre incredibilmente torrido, che ha raccolto il testimone di un settembre altrettanto fuori scala e dell’estate più calda di sempre, in cui abbiamo visto polverizzarsi record decennali in fatto di ondate di calore, alluvioni, incendi e temperature estreme. È stata anche l’estate dei dietrofront e della disinformazione: mentre le ricadute dell’emergenza climatica si facevano visibili come mai prima, il governo italiano votava contro l’approvazione di una legge europea sul ripristino della natura e annunciava di voler tagliare dal PNRR i fondi per la prevenzione degli eventi estremi; nel frattempo i negazionisti climatici tornavano a infestare le trasmissioni televisive, e le aziende del settore fossile registravano profitti record, aumentando i propri piani di estrazione.
In una situazione simile è difficile non cedere al fatalismo. I mulini a vento non sono mai sembrati tanto grandi, le lance che abbiamo passato anni ad affilare a volte paiono stuzzicadenti, persino tra gli scienziati climatici più combattivi qualcuno comincia a mostrare segni di scoramento.
Negli ultimi mesi ho avuto decine di conversazioni su questo tema, e sebbene il ventaglio di reazioni che ho raccolto sia molto più variegato del telefono senza fili di Toyokawa, molti di questi scambi tendevano a incurvarsi su una nota fatalista, una variazione di “comunque ormai non c’è niente da fare”, una chiosa spesso accompagnata da un sorriso obliquo, che la faceva suonare più come una rassicurazione che una condanna; come a dire: ok, il mondo sta finendo, ma ogni sforzo si è rivelato vano, perciò tanto vale vivere la nostra vita e sperare per il meglio.
“Scrivo queste parole nei primi giorni di un ottobre incredibilmente torrido, che ha raccolto il testimone di un settembre altrettanto fuori scala e dell’estate più calda di sempre.”
Prima di proseguire, è opportuno sgombrare il tavolo da questi dubbi: non è vero che non ci sia più niente da fare, come non è vero che il tempo per arginare la crisi climatica sia scaduto. Non più tardi di fine settembre l’Agenzia Internazionale per l’Energia ha ribadito che siamo ancora in tempo ad adottare le misure necessarie a mantenere il riscaldamento globale al di sotto degli 1,5 gradi, una soglia entro cui abbiamo ragione di credere che il nostro mondo possa mantenere ampi margini di vivibilità.
Esistono moltissimi strumenti che possono essere impiegati già oggi per decarbonizzare le nostre economie, ripristinare e potenziare i sistemi naturali di assorbimento della CO2 e intervenire sui settori più inutilmente impattanti, come il trasporto urbano e lo spreco alimentare. Queste soluzioni non sono mai state tanto convenienti e a portata di mano.
È anche vero, però, che la finestra temporale per agire si sta riducendo giorno dopo giorno, e che l’umanità non ha mai portato a termine una sfida tanto imponente: avviare una reale decarbonizzazione non è solo questione di premere il bottone giusto, è una sfida complessa, trasversale, che richiede di adottare decine di misure trasformative in parallelo, di mettere in discussione un sistema economico e di potere pesantemente incardinato ai combustibili fossili. Non stupisce che la maggior parte di noi fatichi a visualizzare un simile cambio di paradigma.
Ma se anche chi si occupa quotidianamente di clima a volte si lascia irretire dalle sirene del fatalismo non è solamente per le proporzioni soverchianti di questa sfida, è anche perché l’evoluzione ci ha dato in eredità un cervello molto bravo a preoccuparsi per il futuro, ma molto scarso nell’immaginare un cambiamento radicale positivo.
2. Perché fatichiamo a credere che le cose possano cambiare
Hermann von Helmholtz l’aveva intuito nel 1867, più di un secolo dopo le neuroscienze hanno cominciato a confermarlo: non siamo macchine fotografiche con l’obiettivo aperto, intente a collezionare impressioni della realtà in modo passivo e acritico. Il nostro cervello funziona più come una macchina predittiva, costantemente impegnata a combinare le informazioni che otteniamo dal mondo esterno (immagini, suoni, parole, esperienze) con le nostre aspettative su di esso.
Nel saggio Surfing Uncertainty, il filosofo cognitivo Andy Clark la spiega così: “Per far fronte in modo rapido e dinamico a un mondo incerto e pieno di interferenze, il nostro cervello è diventato un maestro della predizione: un po’ come un surfista esperto, cavalca le onde di stimoli sensoriali ambigui cercando di stare appena più avanti del punto in cui l’onda si infrange.”
C’è una ragione evolutiva per questo sbilanciamento in avanti: se dovessimo affidarci costantemente alle informazioni che arrivano dall’esterno per interpretare la realtà andremmo incontro a un dispendio energetico poco sostenibile. E come sappiamo l’evoluzione tende a premiare le direzioni più parsimoniose: mantenere attiva una simulazione mentale della realtà esterna, da modificare solo all’occorrenza, costa molta meno energia.

“È come se il cervello fosse costantemente occupato a dipingere un quadro” specifica Clark in un altro saggio, il più recente The Experience Machine “e il ruolo delle informazioni sensoriali è principalmente quello di correggere le pennellate quando non corrispondono all’evidenza. […] Niente di ciò che facciamo o percepiamo è al riparo dalle nostre aspettative.”
In altre parole, la realtà che sperimentiamo è appesantita dall’idea che ci siamo fatti di essa. E questo, com’è intuibile, non influisce soltanto su come guardiamo al presente, ma anche su come immaginiamo il futuro. Johann Wolfgang von Goethe ci era arrivato già nel XIX secolo: “Vediamo solo ciò di cui andiamo in cerca”, scrisse, “e andiamo in cerca solo di ciò che conosciamo”. Andare in cerca solo di ciò che conosciamo, oggi, significa aspettarsi che il futuro non sarà troppo dissimile dal presente o dal passato, ma anche dalle prospettive letterarie e cinematografiche che hanno forgiato il nostro immaginario speculativo. Prospettive che spesso raccontano un’umanità schiava della propria ingordigia, civiltà incapaci di trovare soluzioni collettive alla propria estinzione, o un mondo che ritorna sano e rigoglioso dopo la scomparsa degli umani.
Una delle caratteristiche che meglio contraddistinguono l’essere umano è la capacità di effettuare quello che i neurologi chiamano “viaggio nel tempo mentale”: è quello che facciamo ogni volta che ricordiamo (e riviviamo esperienze passate) e ogni volta che immaginiamo il futuro (e pre-viviamo potenziali esperienze future). Il motore neuronale di queste proiezioni è lo stesso, e ormai abbiamo svariate prove che le nostre previsioni future sono costruite utilizzando i nostri ricordi come mattoni.
Poiché aspettative e credenze agiscono da filtro sulle nostre proiezioni, ci risulta particolarmente difficile immaginare che la crisi climatica non sia solo la fine di un mondo insostenibile ma anche l’inizio di un mondo più ecologicamente, psicologicamente e anche economicamente sostenibile; e questo anche per via della retorica diffusa che tende a bollare ogni prospettiva di cambiamento radicale come “idealista” o “utopica”.
3. A chi fa comodo il fatalismo
Qualche anno fa, nel luglio del 2018, un professore di Sustainabilty Leadership di nome Jem Bendell autopubblicò un articolo intitolato: Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy, in cui introduceva il concetto di “adattamento profondo”. Secondo Bendell il tempo per arginare la crisi climatica sarebbe ormai scaduto, il collasso della nostra società sarebbe prossimo, e dunque la cosa più ragionevole da fare sarebbe impiegare tutte le nostre risorse per proteggerci il più possibile dai danni devastanti che il disastro porterà. Detto in altro modo: dobbiamo cambiare il mondo, sì, ma non tanto per renderlo sostenibile, quanto per trasformarlo in una scialuppa di salvataggio.
Ora, come ha ben spiegato il climatologo Michael Mann nel suo saggio La nuova guerra climatica (Edizioni Ambiente 2021), le previsioni catastrofiste di Bendell sono pura speculazione e non sono supportate in alcun modo dalla letteratura scientifica. Il problema è che quell’articolo è stato scaricato da più di 600.000 persone ed è ancora oggi sbandierato da chi ha interesse a distogliere l’attenzione dal problema climatico
Negli ultimi 50 anni le aziende del settore petrolifero hanno investito fior di milioni nel tentativo di ritardare l’azione climatica. Sono state le prime ad avere contezza del rischio a cui andavamo incontro, e dunque le prime a intravedere la possibilità che la loro gallina dalle uova d’oro venisse soppressa anzitempo. Pur di scongiurare la fine del sistema fossile non hanno lasciato nulla di intentato: hanno creato gigantesche campagne di disinformazione e depistaggio; hanno messo a libro paga squadre di scienziati prima per negare l’esistenza del riscaldamento globale, poi per sostenere che facesse bene al pianeta, poi ancora per diffondere dubbi sull’origine antropica del problema, infine per sconfessare un’emergenza climatica ormai in corso. Ancora oggi, Big Oil impiega qualunque strumento possa contribuire ad allontanare le persone dalla prospettiva di un mondo decarbonizzato; e purtroppo per noi il cinismo e il catastrofismo sono strumenti molto efficaci in questo senso.
4. Il cugino presentabile del negazionismo
Credo che oggi il fatalismo rappresenti una minaccia più concreta e insidiosa del negazionismo climatico. In primo luogo perché può diffondersi più facilmente: è più socialmente accettabile affermare che la crisi climatica sia inevitabile rispetto a negarne l’esistenza; in secondo luogo perché ha l’effetto di demotivare quanti potrebbero impegnarsi attivamente, stemperando così la speranza in un’azione collettiva; infine perché abbandonarsi a prospettive catastrofiste significa dare il fianco a quanti non aspettano altro che liquidare le preoccupazioni climatiche come deliri allarmistici.
Come dicevamo all’inizio, però, il fatalismo può anche risultare deresponsabilizzante, una prospettiva confortevole, quasi consolatoria, soprattutto per chi vive in condizioni di privilegio sufficienti a poterla abbracciare. Penso ad altri illustri scrittori, ricercatori, giornalisti che, in varie misure, hanno mostrato il loro fatalismo negli ultimi anni: Jonathan Franzen, Roy Scranton, Michael Moore e, sotto certi aspetti, anche David Wallace-Wells e Vaclav Smil. Tutte persone che conoscono bene il problema, e che probabilmente hanno a cuore il futuro di questo pianeta. Ma per quanto virtuose possano essere le ragioni che le muovono – e non ho elementi per credere che siano in malafede – il loro disfattismo finisce paradossalmente per fare il gioco di chi il problema continua ad alimentarlo.
“L’evoluzione ci ha dato in eredità un cervello molto bravo a preoccuparsi per il futuro, ma molto scarso nell’immaginare un cambiamento radicale positivo”.
Il risultato è che oggi il fatalismo climatico è un virus sempre più diffuso. Basti pensare che persino tra gli under-25, una fascia demografica tendenzialmente più informata e proattiva riguardo a queste tematiche, la maggioranza si dichiara fatalista. Uno studio condotto su 10.000 giovani di 10 diversi paesi ha infatti rilevato che, a fronte di un 84% che si dichiara preoccupato per il futuro del pianeta, il 51% afferma di sentirsi impotente, mentre il 56% non esita a concludere che “l’umanità è spacciata”.
È il bollettino di un’epidemia cognitiva preoccupante, che ancora oggi sottovalutiamo e a cui spesso inconsapevolmente mostriamo il fianco. Perché la realtà è che oggi gli agenti virali del fatalismo più insidioso non sono i vari Bendell e Scranton: siamo noi.
5. Pensarlo ma non dirlo
È il caso che mi sieda dalla parte dei colpevoli: è capitato anche a me di dire che non c’è più niente da fare, che la partita è impossibile da vincere. A volte l’ho fatto pattinando su un’ironia un po’ cinica, altre volte spinto dalla stanchezza e lo sconforto per tutte le occasioni che stiamo sprecando. Abbiamo visto come sventolare la bandiera bianca del fatalismo possa risultare tranquillizzante, come una preghiera che placa un credente in un momento di crisi, un mantra ansiolitico che consente di sfiatare tutta l’ansia, il senso di responsabilità e di impotenza, la frustrazione che chiunque inizia a studiare il problema si ritrova ad accumulare giorno dopo giorno. Purtroppo, però, i nostri colpi di tosse fatalisti sono più infettivi di quanto ci verrebbe naturale pensare. Quello che per il singolo individuo può essere un innocuo momento di sfogo rischia infatti di produrre ripercussioni reali sulle persone che lo circondano, andando a rinforzare dubbi e timori che magari covano in silenzio da tempo.
Nel saggio Cambiare (IlMargine, 2021) il sociologo americano Damon Centola spiega che le idee più ambiziose e radicali, che solitamente implicano un coinvolgimento personale, rispondono alle dinamiche del cosiddetto “contagio complesso”. Ovvero: perché prendano piede non è sufficiente che una persona venga esposta a una nuova prospettiva, è fondamentale che abbia l’impressione di non essere la sola ad adottarla. Laddove i contagi semplici si servono di legami deboli, ossia di interazioni tra persone che non necessariamente si conoscono (è il caso dei virus, dei pettegolezzi, dei meme, eccetera), i contagi complessi richiedono legami forti, e si diffondono più facilmente se possono sfruttare reti di conoscenza già consolidate.

Non è un caso, per dire, che molti ex-fumatori dichiarino di aver rinunciato alle sigarette dopo che l’avevano visto fare ad altre persone della loro cerchia sociale. Allo stesso modo la scelta di dedicarsi all’azione climatica, o di adottare pratiche sostenibili, o anche solo di credere alla possibilità di una transizione ecologica, viene favorita da una ridondanza di stimoli e conferme da parte delle persone più vicine. Questo implica che la diffusione di queste idee e comportamenti sia molto più lenta, ma anche molto più robusta e duratura.
Il fatalismo non è un’idea complessa, non rappresenta una sfida personale per l’individuo, è più una disposizione passiva, una rinuncia autoassolutoria. Quindi si propaga più velocemente, andando a sottrarre elementi di rinforzo al contagio lento e complesso dell’azione climatica. Considerando la complessità dell’argomento climatico e la qualità media scarsa dell’informazione su queste tematiche, lo sfogo fatalista di chi è più consapevole e informato rischia di neutralizzare la già debole fiducia in un cambiamento autentico e trasversale. Alla fine, per quanto ci possa suonare assurdo, possono risultare più dannose le falsità che mormoriamo al tavolo di un bar, di quelle urlate davanti a una platea nutrita, o pronunciate a un tavolo internazionale, o scritte in un articolo.
La mattina del 15 dicembre 1973 la Banca del Giappone tenne una conferenza stampa per assicurare a tutti che la Toyokawa Shinkin Bank non era da considerare a rischio. Per ristabilire la normalità, la Banca centrale dovette mettere a disposizione a una vagonata di contanti. Il direttore si fece addirittura fotografare davanti al caveau, accanto a un enorme cumulo di banconote. La profezia si era autoavverata, ma esistevano soluzioni immediate che consentivano di salvare la situazione all’ultimo.
“Il fatalismo non è un’idea complessa, non rappresenta una sfida personale per l’individuo, è più una disposizione passiva, una rinuncia autoassolutoria”.
Nel caso della crisi climatica purtroppo non esistono uscite d’emergenza. Bisogna tenerne conto, perché se tre liceali che chiacchierano per strada possono innescare una crisi bancaria, centinaia di migliaia di persone che vanno in giro dicendo che l’umanità è spacciata possono fare ben di peggio.
Chi si occupa di disinformazione climatica prevede che, di qui ai prossimi anni, con l’intensificarsi delle ricadute della crisi climatica e il restringersi della finestra di tempo utile, il fatalismo sia destinato a soppiantare il negazionismo: del resto è più subdolo, più arduo da disinnescare, più socialmente accettabile, e non è difficile immaginare che prenda piede anche in modo bipartisan.
“A volte penso che se perderemo la battaglia per il clima, sarà in gran parte colpa del comodo disfattismo di chi vive nel nord globale, mentre le persone delle comunità più colpite continuano a lottare con tutte le loro forze per la sopravvivenza”. Lo ha scritto Rebecca Solnit lo scorso 26 luglio. Ha ragione, la sfida che ci attende nei prossimi anni è doppiamente complicata: per poter coordinare una trasformazione economica e politica di proporzioni mai viste nella storia dell’umanità sarà necessario arginare il fatalismo che già oggi si diffonde ai margini del discorso pubblico; un modo per farlo è prendere atto dei limiti cognitivi che ci rendono vulnerabili a questo disfattismo, e prepararci a spezzare i legami del contagio quando parliamo con le persone abbiamo vicine.
Fabio Deotto
Fabio Deotto è scrittore e giornalista. Il suo ultimo libro è L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani, 2021).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati