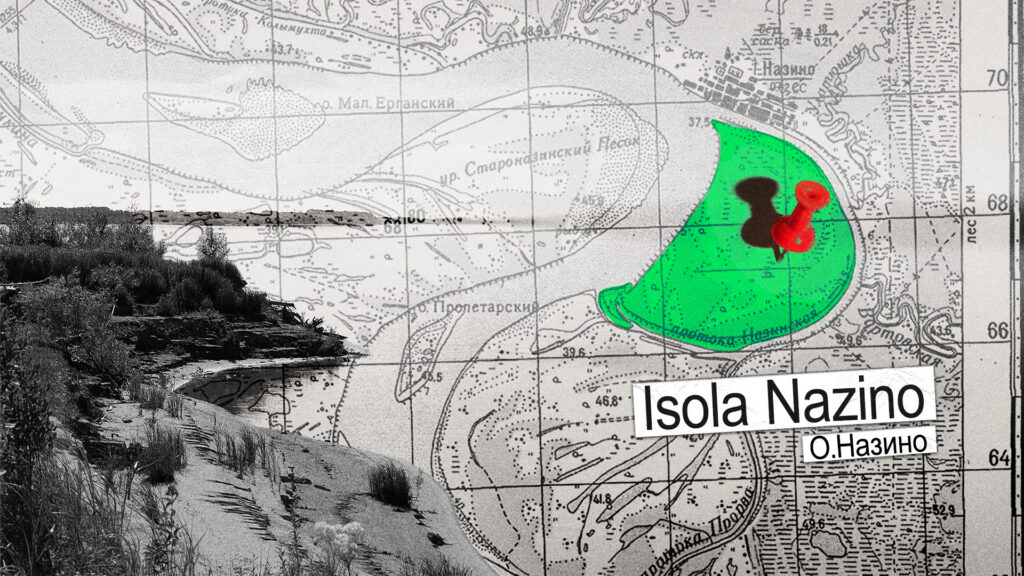Christian Raimo
Fare politica a Roma è una cosa divertente che non farò mai più

16 Ottobre 2023
Fare politica pratica e “di territorio” è considerata una cosa lodevole, soprattutto da chi non ha voglia di spendersi in prima persona. Ma chi decide di farla si ritrova a vivere un’esperienza tragica, malinconica e ridicola che anche David Foster Wallace forse avrebbe trovato degna di interesse.
Come tutti i racconti di politica, anche questo è ovviamente una storia di educazione collettiva e di gratitudine per i compagni e le compagne, Grande come una città, Osservatorio no Tmb, Terzo in cantiere, Astra 19 e Branca, Luca Blasi, Valerio Renzi, Martina Testa.
La mia cosa divertente che non so se farò mai più è stato chiaramente prendermi un ruolo da assessore per quattro anni, dal 2018 al 2022, in un municipio romano. L’esperienza di amministratore di territorio non diventa praticamente mai oggetto di narrazione. Chi ambienta un romanzo di formazione politica tra i consigli municipali? Quale saggio sulla crisi della sinistra avete letto negli ultimi anni che vi racconta la fatica di scrivere un bando che magari finirà deserto per il boicottaggio strumentale dell’opposizione? A chi interessa qual è la vita di una sezione territoriale, o il rapporto rissoso che c’è tra un comitato di quartiere e una giunta municipale?
Rimpiangiamo spesso i tempi in cui c’era la politica dal basso (ah, il partito, milioni di iscritti!, ah, le sezioni! ah, le scuole di formazione a Frattocchie!), ci si accalorava in infinite discussioni fino alle ore piccole, osservati speciali dalle litografie di Gramsci e Togliatti alle pareti a farci da coscienza in scantinati pieni di fumo; tanto che qui in Italia è quasi un genere cinematografico – La meglio gioventù, Il sol dell’avvenire… – molto in voga negli anni della nostra crisi della politica, quello che ci riporta con nostalgia gli anni Sessanta o Settanta con ragazzi accalcati che si urlano di scioperi e rivoluzione, dandosi appuntamento all’alba per volantinare. Oggi quale produttore farebbe passare una sceneggiatura in cui il protagonista è un giovane militante di quartiere? E se ci pensiamo l’unico film che ha scelto di dedicare una scena madre proprio a un consiglio municipale è una serie televisiva ed è un cartone: Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare.
Eppure. Eppure, forse perché cosa accade nei gradini più bassi della filiera democratica è pressoché sconosciuto ai più, questo racconto potrebbe essere interessante. In una delle pagine più famose del reportage il cui titolo è diventato idiomatico, David Foster Wallace elenca con una serie di “ho visto” bladerunneriani non i bastioni di Orione in fiamme, ma la teoria infinita delle esperienze estreme che il consumismo americano può fare su una crociera extralusso.
La sensazione che si prova con quell’elenco è un misto di afflato e afasia: un monologo tragicomico, surreale, in cui viene scandita una transizione inutile e sublime di noi esseri umani sulla terra, clienti, consumatori, candidati cadaveri. È un pezzo di bravura anaforica di Foster Wallace, è chiaramente una parodia, ma è anche un brano che ci convince nella tesi che troviamo alla fine di Una cosa divertente: la crociera è, in definitiva, un’esperienza premorte, apotropaica e malinconica.
Del resto, quale delle esperienze che facciamo non lo è almeno un po’?
Lo è anche la politica: un modo di esorcizzare la morte, come i figli, la letteratura, il calcio, persino il fantacalcio. E la politica è un modo particolarmente efficace perché, esattamente come i figli, la letteratura, il calcio, o persino il fantacalcio, come le cene da preparare, i romanzi appena usciti da leggere o i classici che non si è ancora letto, le partite di campionato, le aste del calciomercato virtuale, non finisce mai. C’è sempre un’elezione fra qualche mese, c’è sempre un’assemblea a cui si dovrà partecipare, ma soprattutto c’è sempre qualcosa di cui potersi occupare, un tema, urgente anche in una desolata domenica pomeriggio, anche in una notte insonne.
Però la consapevolezza di questa capacità esorcistica (di rimozione? di evitamento?) del fare politica ce l’ho avuta tempo dopo: l’istinto a dedicarmici mi era sembrato tra il 2017 e il 2018 più puro – idealismo, non compromissione – , ma anche strategico. Potrei scomodare parole come vocazione e occasione, la klesis e il kairos, che i Vangeli e soprattutto San Paolo nominano rispetto alla chiamata cristiana. Nel casino delle nostre vite, determinate quasi tutte da causalità e scelte condizionate al ribasso, nel casino di scelte goffe, rappezzate, sconclusionate, compromissorie, vili, a un certo punto mi era sembrato che fosse il tempo per me di dedicare un po’ di tempo in più alla politica, pratica, di territorio, a Roma, dovunque fossi, dovunque mi capitasse.
Erano successe due cose.
La prima era stata lo sgombero di una palazzina occupata a Piazza Indipendenza, a un passo dalla stazione Termini, nell’agosto del 2017. Il 19 agosto all’alba la polizia era comparsa in massa all’improvviso, blindati e assetto antisommossa pronto all’uso, circondando lo stabile con l’ingresso su via Curtatone, tra la sede de «Il Sole24 ore» e quella di una banca, che ospitava in quel momento almeno 250 famiglie, circa mille persone, la maggior parte delle quali di origini eritree e titolari dello status di rifugiato o di qualche forma di protezione internazionale, che stavano autogestendo quello spazio dal 2013. Lo sgombero si era trasformato in un’agonia prima – le famiglie che non se ne volevano andare, con centinaia di bambini avevano occupato i giardinetti antistanti e si erano piantati sotto il sole e all’addiaccio – e poi in una caccia all’uomo quando venne deciso di fare letteralmente piazza pulita.
“Lo è anche la politica: un modo di esorcizzare la morte, come i figli, la letteratura, il calcio, persino il fantacalcio”.
Roma era ancora quasi deserta, era estate. A dare solidarietà agli eritrei erano arrivati attivisti, cittadini indignati dalla violenza dello sgombero, volontari di associazioni, buoni in ordine sparso. Anche io: impossibilitato o caratterialmente incapace di fare vacanze lunghe, andavo spesso quell’estate nella redazione di «Internazionale» che era a pochi metri, via Volturno, l’ufficio con l’aria condizionata assorbito nel riadattarsi con lentezza alla routine feriale.
Un giorno di quella fine agosto eravamo usciti in pausa pranzo e avevo rischiato di finire colpito dalle cariche della polizia, avevano dato una mezza scudisciata a una collega per sbaglio, eravamo risaliti in redazione scossi, e ci erano arrivate le immagini delle agenzie con quelle cariche. Un pezzo del «New York Times» del giorno dopo raccontava quello che potevamo vedere dalle finestre di quella stessa redazione che a sua volta poteva tradurlo e diffondere sul proprio sito la notizia che, nel frattempo, diventava giocoforza la prima notizia nazionale con un rilievo.
Mi aspettavo a quel punto che tutti i politici si mobilitassero per la causa, fosse anche per un quarto d’ora di visibilità a favore di telecamera, un lucro automatizzato. E invece: rimanemmo in pochi, lì sotto. Qualche attivista, qualche giornalista, qualche politico locale, qualche rappresentante di un’ong che si occupava di migrazioni.
Passammo le giornate a provare a interpellare i politici, che fossero interlocutori, alleati, rappresentanti. Non ci rispose quasi nessuno. Annoiati, telefoni staccati, ancora in vacanza, indaffarati in altro, indifferenti. Poter coprire così efficacemente la notizia non produce, mi dicevo, nessun effetto. Denunciamo, ci indigniamo, amplifichiamo la voce delle persone che stanno subendo un’ingiustizia plateale, le foto con gli idranti sparati su donne inermi fanno il giro del mondo, ma questo non modifica nulla.

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, lo sgombero durò quasi dieci giorni, la scena diventò sempre più estenuante, le famiglie erano fiaccate, e io mi sentivo come di stare in una vecchia striscia di Mafalda di Quino. C’è il padre che si rivolge alla madre e le chiede un piccolo favore, la madre si volta e si rivolge allora a Mafalda e le richiede il favore, che a sua volta si rivolge al fratellino Nando per il favore, finché nella quarta vignetta c’è Nando che guarda verso la parete e, deluso, non trova nessuno.
La sensazione che ho in quei giorni è di essere come Nando. Gli sgomberati in strada si rivolgono a quei pochi che siamo, lo fanno in continuazione, ci chiedono informazioni, sostegno, di intermediare, di farci carico della loro battaglia presso chi può decidere e dargli scampo. Noi vorremmo, ma i politici non si fanno vedere, non rispondono, sono ancora in vacanza, pensano che sia bene che finisca così, la liquidano come una mera questione di ordine pubblico. Come Nando guardo la parete vuota, l’aria calda, lo spiazzale con i vestiti buttati in strada, continuo a chiedere un intervento di politici, rappresentanti, decisori, qualcuno che si muova sul serio, che faccia qualcosa, che blocchi quello che sembra un pogrom, in pieno sole; e alla fine con molta frustrazione capisco che questi altri politici sono personaggi immaginari, non esistono. Un decennio lunghissimo di antipolitica ha cancellato interlocutori, alleati, avversari, tutto: siamo rimasti noi e la polizia, e i rifugiati inermi.
Tutto finisce nel niente, nei giorni successivi allo sgombero l’Ama lava la piazza con particolare cura, poi per diversi mesi, in modo illegale, un’intera strada viene transennata e privatizzata; oggi lo stabile di via Curtatone è stato già ristrutturato, diviso e riassegnato a varie società, tra cui diverse multinazionali, per usarlo come sede prestigiosa; da un anno c’è anche una palestra Virgin. A che serve fare i giornalisti, raccontare le cose, andare nei posti, che sia sul campo di battaglia o comodi in una redazione a tradurre il «New York Times», se poi questo non modifica né la percezione né ispira una spinta alla mobilitazione?
Il secondo evento importante era stata la morte di Alessandro Leogrande. Era arrivata in una metà mattinata di novembre 2017 la notizia confusa, incredibile. Era una di quelle giornate ovvie, di caos costante, di pulviscolare richiesta d’attenzione, e di lavoro parcellizzato, a cui siamo abituati; solo che la notizia non era: hai visto il pezzo di Alessandro Leogrande, hai visto la polemica su Alessandro Leogrande, ma È morto Alessandro Leogrande. Le persone muoiono, anche le persone giovani muoiono, ma la morte di Leogrande aveva una ragione in più per essere uno schianto incredibile per noi, che eravamo suoi amici, colleghi, compagni. Alessandro non era soltanto compreso in quel vortice di cose che adesso la notizia della sua morte interrompeva, lui era la parte migliore di quel vortice. Era l’assemblea con i sindacalisti dei lavoratori stranieri della logistica, era lo studio per il libro dei documenti dei desaparecidos in Argentina, era l’analisi a caldo delle elezioni regionali. Diversamente dalla maggior parte di noi: non era soltanto interessato a quello che accadeva o a un tema per un saggio da consegnare la settimana prossima, ma era coinvolto in quello che accadeva e che studiava, e cercava di comprendere, persino intuire, come produrre azione dalla conoscenza e viceversa. Non ce lo dicevamo, nemmeno io a me stesso, ma era un modello professionale e soprattutto politico. Ci faceva sentire – per fortuna – in colpa. Era un antidoto a quel genere di impasse di cui piazza Indipendenza era l’emblema.
“Un decennio lunghissimo di antipolitica ha cancellato interlocutori, alleati, avversari, tutto: siamo rimasti noi e la polizia, e i rifugiati inermi”.
A caldo, qualche ora o qualche giorno, dopo, Nicola Lagioia, anche lui amico di Alessandro, acceso da un istintivo, però giusto in fondo, slancio rispetto al compito da cui ci si sente investiti quando un compagno di strada muore, mi ripeteva al telefono, nelle chiacchiere dopo il funerale, che avremmo dovuto fare ancora di più, impegnarci ancora di più ora. Ma io anche a caldo avevo ben presente la dimensione della tragedia: Alessandro era insostituibile. Incarnava in sé dei saperi e delle reti di relazioni che era difficile se non impossibile mappare o riconoscere, figuriamoci replicare. Chi aveva la possibilità di studiare il pensiero meridionalistico e connetterlo alle nuove lotte della gig economy? Chi aveva le sue conoscenze nelle procure e le passava al vaglio delle riflessioni sulla polizia che ricavava dalla sociologia francese o dai polar scandinavi?
Lontano dagli intellò, dai vecchi maestri incapaci di lasciarsi smentire, dai firmatari seriali di appelli, persino dai maschi performativi, era il migliore, in tutto quello che facevamo, o meglio in tutto quello che facevamo con la coscienza di quanto fosse veramente importante. Non era quello che arrivava più velocemente a trovare la chiave per ragionare su un evento, non era quello più esperto su un tema, non era il più brillante a parlare in pubblico, ma era quello che lo faceva meglio di tutti, inseguendo in qualche modo, con lucidità, un’idea di bene perennemente collettiva, politica. Aveva una misura della ratio intellettuale novecentesca, molata e riadattata ai tempi guasti del precariato e dei conflitti ambientali.
Così la morte di Alessandro Leogrande è stata per me determinante rispetto all’esigenza di trasformare la possibilità di fare politica in necessità; e in qualche modo il debito nei suoi confronti, come nei confronti di molti altri, era quello di smettere, o almeno di cambiarsi spesso i panni dell’intellettuale militante, e di fare semplicemente il militante.
Nell’estate del 2018 venni invitato da Giovanni Caudo, professore di Roma Tre, indipendente di centrosinistra, ex assessore nella scandalosamente crivellata da gragnuole di fuoco amico giunta Marino, che aveva deciso di candidarsi a presidente del Terzo Municipio di Roma, a fare l’assessore alla cultura della giunta municipale.
È un microscopico ruolo, non ho tessere di partito, e tolgo un posto a una delle persone che si è candidata ed è stata eletta nel consiglio comunale, apparentemente non ho dimestichezza con la politica territoriale.

Nei primi mesi del mandato mi dedico a promuovere una serie di iniziative con un semplice scopo: costruire una comunità politica. Quella che mi sembra la questione più grave della doppia crisi di rappresentanza – intellettuali che animano il dibattito pubblico, ma non fanno militanza attiva, non si iscrivono a un partito, non partecipano a assemblee, non fanno picchetti; politici che non si propongono né accettano di essere referenti di movimenti politici, delle lotte, delle istanze, delle emergenze – è che le persone che fanno politica attivamente, tutti i giorni, che dedicano molto tempo alla politica, sono sempre meno, sono spesso sole, sono sfrante di stanchezza.
Mi sembra quindi prioritario comprendere quale sia il bisogno di partecipazione, suscitarne di nuovo, e soprattutto riflettere – elucubrare, sperimentare – su come educare alla militanza e come organizzarla. Quel poco che esiste e resiste in Italia, da Nonunadimeno ai No TAV fino alle nuove piazze ecologiste, viene costantemente considerato estremista quando non viene militarmente represso.
Ma non è questo il problema principale quando comincio a partecipare alla “politica dal basso”. Il problema è invece il Pd. Non avevo mai visto il Partito democratico da vicino; ne avevo seguito le polemiche interminabili sui giornali, ma non mi ero reso conto di cosa significasse avere a che fare con questo fenomeno strano che era il Pd, in special modo il Pd romano, o una parte consistente del Pd romano che coincide almeno metonimicamente con il tutto.
Il Pd romano ha una cattiva fama, la vicenda Marino appunto – l’opposizione de facto alla sua giunta (2013-2015) da parte di una serie di consiglieri del Pd, che riescono a farla cadere – ha mostrato come sia incistata dentro la struttura del partito una forma di correntismo talmente infingarda da confondere persino il sabotaggio con l’autolesionismo, non soltanto tagliando il ramo dove ci si siede, ma inscenando da monchi una guerriglia a bastonate.
Ma quando ho a che fare con il Pd dal vivo, sono comunque sorpreso. Le riunioni di maggioranza, convocate sugli ordini del giorno, quelli prevedibili o alcuni pretestuosi, o le riunioni come si dice politiche si svolgono con copioni da commedia dell’arte e inserti di stalli alla messicana. Spesso il livello di livore, risentimento, arroganza, volgarità è tale che diventa impossibile non essere coinvolti, travolti o stravolti.
Il quid della discussione diventa indifferente dopo poco. Che occorra ragionare sul nuovo piano dei trasporti pubblici, o sul rifacimento dei marciapiedi, il confronto si svolge tutto con voci alterate in uno spettro sonoro che va da passivoaggressività a aggressività in purezza, passando per sessismo implicito, sessismo dichiarato, sessismo paternalista, criptosessismo.
Buona parte delle conversazioni si reggono su sticomitie che sono “Mo dovemo inculà quello”, “Se non inculamo quella poi quella ce incula”, “No, quello non ce lo dovemo proprio inculà”, “Ma quella chi se la incula”. Sembra un renactment di uno sketch di Proietti, in cui inculare occupa piano piano tutto il paesaggio lessicale fino a diventare come spam nello sketch dei Monty Python. Inculare è un verbo onnisemantico, che può ritagliarsi accezioni e adattarsi a contesti diversi. “Dobbiamo inculare il comitato prima della delibera, che poi ci incula, con la scadenza regionale del bando per i soldi della cultura, che quest’anno sono un’inculata”.
Io sono in bilico: da una parte sono allucinato, dall’altra l’energia di questa discussione impedisce qualunque forma di distacco, dopo due o tre ore chiaramente ha modellato anche me e probabilmente dopo un po’ comincio a adeguarmi alla nuova grammatica, mitigando con qualche congiuntivo la violenza dei toni: “Ma se noi inculassimo la scadenza prima di venire inculati da un’eventuale inculata di cui non ci saremmo accorti prima?”
Vengo guardato comunque con sospetto, sono un corpo estraneo, devo passare un rito: voglio entrare in questo mondo? Mi devo sporcare. Devo passare ore in cene e riunioni similcondominiali in cui si discute in questo modo, essenzialmente lasciando la parola a maschi anziani o a giovani che imitano maschi anziani, che sono quelli che sanno come si fa politica sui territori. Fumano, alzano la voce, sbattono i pugni, fanno battute da scuole medie a cui tutti ridono.
Quello che sta fuori del Pd non è molto diverso, riproduce con variazioni di stile la stessa grana pastosa di una dialettica senza controllo, in cui non è nemmeno immaginabile la regola di darsi dei turni per parlare, di non sovrastare l’altro, di non invadere lo spazio della discussione. Il gioco linguistico della politica si fonda proprio su questo genere di regole. Finita la riunione, spesso si vorrebbe tornare umani: si lanciano frecciate goliardiche a chi si è insultato fino a poco prima, ci si tocca, buffetti, ci si abbraccia anche. La confidenza fisica è data per scontata, il rispetto no.
È molto complesso riconoscere questa tipologia di cultura politica, perché è nella fenomenologia pulviscolare, nei tic, nei vezzi, nell’ossificazione di certe formule linguistiche che si rintracciano le sue caratteristiche principali. Le posizioni su economia, società, governo della città sono sostituibili.
“Vengo guardato comunque con sospetto, sono un corpo estraneo, devo passare un rito: voglio entrare in questo mondo? Mi devo sporcare”.
Quando a agosto 2022 uscirà su «Il Foglio» il video rubato di Albino Ruberti, dirigente del Pd, in quel momento capo gabinetto del sindaco Gualtieri, soprannominato Wolf (nel senso tarantiniano) che in una cena con compagni di partito e altri stakeholders locali, come si direbbe, sbrocca fino a dire “In ginocchio o ti sparo”, la mia sorpresa è ormai nulla. Conosco Ruberti, un paio di volte c’ho anche parlato di persona, ed è lo standard che un personaggio di primo livello come lui, persino esemplare nella dedizione al lavoro, poi possa sbracare in questo modo in una situazione semipubblica. Non è schizofrenia, non è una doppia morale, è l’esito di una coincidentia oppositorum che si pensa assolutamente funzionale per chi intende il potere in questo modo.
Come interpretare questa rivendicazione di aggressività propalata come status, e questa specie di euforia nella pratica permanente del fuoco soprattutto se amico o amicale?
A un certo punto provo a arrotare una chiave ermeneutica. Il Pd romano è un’entità che prescinde dai singoli – che alle volte presi singolarmente sono persone in gamba, persino in alcuni casi preparate, che svolgono chi meglio chi peggio il loro lavoro politico –, ma è una specie di figura velenosa dello spirito: in termini hegeliani, si manifesta come una neoplasia.
Provo a storicizzare quest’ipotesi di lettura. Il Pd nasce come una entità parassitaria e distruttiva. La sua variante romana è quella più interessante da osservare, dal Lingotto in avanti; l’ideologia veltroniana, che l’ha innervato, ha preso le più importanti culture politiche del Novecento (comunismo, socialismo, cattolicesimo democratico, ambientalismo, femminismo…) e le ha rese prima sterili, poi morte, poi le ha adulterate fino a farle diventare tossiche.

Ogni elemento vivo che ha avuto a che fare con il Pd o ne è stato risucchiato, o si è reso strumentale di questo lavoro di parassitisimo e vampirizzazione. Questo processo non è sembrato totalmente negativo: è giusto che anche un malato tumorale venga nutrito fino all’ultimo se non possiamo operare il tumore; le piante parassitarie possono in alcuni momenti sembrare rigogliose; i vampiri possono persino essere seducenti. Fino a che punto bisogna accettare la natura invasiva, infestante, devastante, e mortale?
Quando però – ed è il caso specifico del Pd romano – il tumore, il parassita, il vampiro si è praticamente nutrito di tutto quello che c’era intorno, e come capita in certe fasi terminali della malattia o in certi film di genere, il Pd aggredisce sé stesso, si autofagocita, alterandosi completamente. Diventa tutto veleno. Il vampiro senza quasi più sangue fresco da succhiare, comincia impazzito a mordere sé stesso fino a diventare un mostro.
Cosa fare da un punto di vista politico rispetto a tutto questo?
Succedono altre due cose.
Il 17 novembre riesco a organizzare un incontro in una scuola con Miguel Benasayag, il titolo è autoeloquente: La necessità del conflitto per la democrazia. Sarà il ventesimo incontro pensato in pochi mesi, in spazi molto diversi, un festival femminista in un tendone da circo durante le feste di Natale, una lezione sulla lingua della Costituzione nel parchetto dei tossici, con quell’idea strategica e velleitaria di educare alla militanza, di immaginare una forma kerigmatica che sia esaltante, inedita, emozionante, non solo una giusta battaglia, il ricatto delle cause già date per perse, ma una lotta fica.
Benasayag s’interessa del modello: quando snocciola la sua biografia politica, il carcere, il Latinoamerica, le banlieue, l’università, si concentra sulle organizzazioni locali: parla poco del suo lavoro di ricercatore, e molto di quello di militante, come gestire le assemblee, il passaggio di consegne – di saperi politici (le passioni liete invece che le passioni tristi; su Spinoza ha scritto tra i suoi testi più importanti) – tra vecchi militanti e giovani compagne… In tantissimi prendiamo appunti, soprattutto su una distinzione che spesso torna nei suoi libri, e che nello spazio dell’incontro – una scuola superiore – sa che deve risuonare didascalica.
La guerra e il conflitto: la guerra vuole annichilire l’avversario e imporre l’annullamento stesso della relazione, della differenza, di pensiero, di biografia politica; il conflitto invece esaltando la dialettica con l’avversario, capisce che solo nel riconoscimento della differenza c’è vita. È evidente anche quando non è dichiarata la sua formazione degli anni Settanta, Deleuze, lo strutturalismo, e soprattutto la filosofia della differenza femminista.
“Diventa tutto veleno. Il vampiro senza quasi più sangue fresco da succhiare, comincia impazzito a mordere sé stesso fino a diventare un mostro”.
Rimugino sulle guerriciole quotidiane che sono il cartellone continuo della stagione politica romana, e mi interrogo su come rovesciare quest’automatismo bellicista in conflitto. Ma soprattutto presto attenzione a Benasayag quando risponde a una domanda affilata, una ragazza al penultimo anno al liceo. “Mi piacerebbe fare politica. Dove comincio?”. Benasayag risponde: “Qui”.
Qui vuole dire dove si è già. Ci sono ingiustizie in ogni angolo del mondo, in ogni strada, in ogni quartiere, in ogni posto di lavoro, persino forse in ogni chat di genitori. Occorre, insiste, avere una prospettiva internazionalista, ma sapere stare nelle lotte che si possono seguire, partecipare alle assemblee, darsi da fare per contrastare le inerzie, le indifferenze, i vuoti (quando va bene), i fascismi (sempre meno raramente) negli spazi che si abita.
Venti giorni dopo, l’11 dicembre 2018, va a fuoco il tmb Salario. Un fungo nero, similatomico, viene generato da un incendio che si innesca e devasta l’impianto di via Salaria, tra villa Ada e il Raccordo anulare, coinvolgendo con fumi tossici l’intera città: l’immagine di una colossale colonna nera che si allarga nel cielo è memorabile, diventa una delle icone catastrofiche dell’amministrazione Raggi ma anche dell’incombere di disastri cittadini ovunque, sempre, improvvisi e seriali, come gli autobus in fiamme o gli allagamenti. La vertenza su quell’impianto durava da quasi dieci anni, ed era arrivata a coinvolgere, nei giorni peggiori (quasi tutti nella cronicizzazione dell’emergenza rifiuti) i cittadini di un’area grande almeno due municipi, il secondo e il terzo, cinquecentomila abitanti.
Per me è diventata una ragione di vita. Conosco centinaia di persone che soffrono quotidianamente, giorno e notte, di quell’ingiustizia, alcuni sono amici, altri lo sono diventati, sono tutti compagni, e anche io sono stato intossicato per un più di un anno dalla vicinanza all’impianto. Così decido di essere dedito alla causa: partecipo a ogni assemblea, faccio presìdi, proteste situazioniste, mi spendo persino il giorno di Ferragosto con un picchetto simbolico. Assomiglia a un’ossessione. I miei altri amici mi guardano perplessi, come un triggerato che non sa come districarsi.
Perché battersi così maniacalmente per chiudere un tmb, un impianto di trattamento meccanico-biologico, e – soprattutto per revocare l’Aia, l’autorizzazione di impatto ambientale? Perché mi sono convinto che l’insofferenza e la rabbia di chi abita vicino al tmb Salario non sono un’espressione nimby, ma uno dei sintomi di un deficit di sistema, forse il più importante, che riguarda la politica a Roma.
Ma. Ma occuparsi di rifiuti è noioso, comprendere come funziona la raccolta, la trasferenza, la raccolta dei materiali, pupparsi le sedute municipali, comunali, informali, improvvisate, nel retro della sala parrocchiale, nel parcheggio del supermercato, con comitati, sindacalisti, leggere report analitici, fiacca, stanca, tedia. E così, di rifiuti si parla, tra persone impegnate, tra persone di buona volontà, anche tra militanti di sinistra, con un’indignazione basica, non è possibile, mai vista una città così sporca, gabbiani, cinghiali, e questo, questi pochi minuti, queste poche chiacchiere, questo stare dalla parte del giusto anche se ovvio, sembra bastare, a sedare per qualche ora l’ansia da impotenza.
Quando va a fuoco il tmb Salario, e l’impianto di trattamento viene lesionato in modo così grave da non consentire la sua ristrutturazione, provo un senso di sollievo e sconfitta. È una lotta finita male; qualcuno gli ha dato fuoco.
“Ci sono ingiustizie in ogni angolo del mondo, in ogni strada, in ogni quartiere, in ogni posto di lavoro, persino forse in ogni chat di genitori”.
Le indagini accerteranno che si tratta di un incendio doloso, ma non sapranno attribuire le responsabilità – telecamere rotte, troppe complicità all’interno dell’azienda, una manutenzione già carente che ha agito da concausa. La sconfitta è nel non essere riusciti – noi – a vincere una lotta bene.
La sconfitta mia è quella, in anni di dedizione alla causa, articoli sui giornali, di accorati tentativi di spiegazione e di coinvolgimento sul tema, di arringhe private persino con il pm Pignatone che ci congederà con un’alzata di spalle, di non essere riuscito a far capire quanto la questione del tmb, e, in generale, dell’impiantistica per i rifiuti a Roma fosse determinante, la questione romana. Si parla di transizione ecologica, ma la maggior parte delle persone non ha la minima idea di come avvenga il ciclo dei rifiuti nel posto in cui vive, non spende un’ora sola del suo tempo sul tema, ma continua a subire il violento effetto di una città subissata di rifiuti, cresciuta e pacificata da una cultura politica antiambientalista.
Nel 2016 scrivo un lungo reportage sui rifiuti per «Internazionale», provo a essere brechtiano in quanto a resa pedagogica. Tra le altre cose mi accorgo che il vero nodo è la scelta della collocazione degli impianti, e che queste decisioni – che sono in carico alla responsabile tecnica della regione – mi paiono davvero incomprensibili; è lei, la responsabile tecnica della regione, tra l’altro che decide di prorogare l’autorizzazione per il tmb, senza nemmeno dare peso alle denunce dettagliatissime, clamorose dell’Arpa. La affronto in assemblee un paio di volte. La intervisto un paio di volte. Penso che o è un po’ scema, o c’è qualcosa che non torna. La responsabile tecnica si chiama Flaminia Tosini. Non è un po’ scema. Viene arrestata nel 2021, con le accuse di corruzione, concussione e turbativa d’asta. Del processo che si sta svolgendo in questi giorni non c’è traccia quasi da nessuna parte.
Lo racconta TusciaWeb, una notizia del 30 settembre 2023.
La famosa inchiesta salita agli onori della cronaca come “rifiuti & gioielli”, in quanto Lozza avrebbe regalato alla Tosini, in cambio delle sue attenzioni nei confronti delle sue attività imprenditoriali, viaggi e vacanze in luoghi esotici, borse firmate e preziosi acquistati nelle gioiellerie più chic della capitale. A riportare l’ultima udienza è Agenzia Nova. Le decisioni che venivano prese, in merito alle autorizzazioni per le discariche nel Lazio, secondo quanto riportato, sarebbero state condivise con l’allora amministrazione guidata da Nicola Zingaretti. “Sembra che ero soltanto io a decidere, come se fossi il genio del male. Ma insieme a me c’era anche il presidente della Regione Lazio, il vicepresidente, l’assessore alla sanità, ma anche uffici ministeriali”, ha detto Tosini.

Il processo farà il suo corso. Ma in questi giorni, dopo non essere stato operativo per quattro anni (nel 2019 riuscimmo a far togliere l’Aia), verrà invece inaugurata una nuova autorizzazione, per accogliere terre di spazzamento, e forse anche la trasferenza (i rifiuti che vengono portati da un’area dell’Ama all’altra).
Ad aprile 2022 – per suggellare con una chiosa simbolica questa lotta contro una violenza sociale di durata più che decennale (immaginate cosa vuol dire abitare in un posto dove l’aria sa sempre di cassonetto), originata da una decisione scellerata presa all’inizio degli anni dieci da Mario Di Carlo, consigliere regionale Pd e soprattutto presidente Ama a suo tempo, che per risparmiare sui costi di benzina dei camion, diede il lasciapassare per situarlo accanto alle case, quartieri popolosi, ceto basso –, come ultimo atto da assessore, mi metto per mesi a organizzare un concerto del Teatro dell’opera di Roma dentro il tmb Salario, tra le vasche del compostaggio e il cadavere bruciato dell’impianto, vicino al parcheggio di scambio tuttora funzionante per i mezzi dell’Ama.
È un progetto herzoghiano in salsa coatta. E come nei suoi film, accade. Assistiamo a una lezione di Luca Serianni sul linguaggio dell’opera, poi a un duetto di un giovane violinista e un giovane pianista, e poi a un coro, quattrocento persone a ascoltare, mentre il tramonto rosso cala sui parallelepipedi di cemento da brutalismo esteuropeo che contengono ancora residui combusti. Ce l’avevo nel cuore, mi commuovo mentre lo vedo accadere, mi sembra una minima forma di restituzione simbolica di bellezza, per chi – per anni – non si era potuto nemmeno permettere una cena sul balcone di casa. A aprile 2022 mi illudo che i saluti alla fine del concerto siano i titoli di coda.
E invece: questa fine non è la fine. A ottobre 2023, mentre scrivo questo pezzo, la puzza è ritornata, sono ricominciate le assemblee, come una recidiva che non sai se avrai la voglia e la capacità di combattere. L’assessora all’ambiente Sabina Alfonsi e il sindaco Roberto Gualtieri hanno deciso di riutilizzare il tmb Salario nel ciclo dei rifiuti senza che questo luogo – nonostante le centinaia di dichiarazioni di l’università della sostenibilità, il polo della transizione ecologica… – abbia mai cambiato di segno.
Il titolo originale del saggio di Foster Wallace è A supposedly fun thing I’ll never do again. Nella traduzione italiana quel supposedly è scomparso; sarebbe stato difficile da rendere, presuntamente?: farraginoso, cacofonico. L’ironia della formula rimane la stessa, forse però si perde un po’ il grado di analiticità, di problematizzazione, di prospettiva politica sul linguaggio che Foster Wallace inoculava in ogni enunciato, in ogni scelta lessicale.
“Assomiglia a un’ossessione. I miei altri amici mi guardano perplessi, come un triggerato che non sa come districarsi”.
Perché quell’avverbio evoca una richiesta di attenzione invece che di intrattenimento. Foster Wallace sa di essere divertente, sa che ha scritto un personal essay che diventerà un modello inarrivabile per chiunque vorrà scrivere un reportage brillante e definitivo su un fenomeno x della cultura contemporanea, ed è consapevole – il suo testo è eccitato: pubblicato in rivista, su «Harper’s», originariamente, traspira come una voce, vuole che il lettore lo segua nonostante le digressioni, le note tecniche, gli incisi, l’aggettivazione pletorica – del tentativo che sta mettendo in atto: intrattenere su un argomento noioso, applicare le migliori armi di comicità intelligente della sua scrittura a qualcosa di apparentemente poco interessante: i rapporti di classe dei lavoratori della navigazione turistica, il gigantesco settore dell’industria crocieristica con la sua evidente finanza speculativa, l’estrattivismo turboconsumista di qualunque forme di vita da quell’esperienza che chiamiamo divertimento. Sa che la noia è noiosa e ha preparato una santabarbara linguistica per farla esplodere.
Nel tempo lui stesso riconoscerà i limiti di quest’estetica: il suo pubblico di lettori è veramente disposto a mettersi in discussione o si ingolla voracemente l’entertainment e scarta a un lato del piatto tutto quello che odora di faticoso?
L’ultimo libro che non finirà – lasciando il manoscritto sul tavolo nella casa dove si impicca – è Il re pallido, e sarà programmaticamente un libro sulla noia: un romanzo ambientato nell’Agenzia delle entrate statunitense.
Dopo il suo suicidio non ho letto Foster Wallace per qualche anno, fino a quando non ho cominciato a fare l’assessore. Mi sono ricordato di quando in un’intervista aveva citato la sua serie preferita, The wire. Ho ripreso quell’intervista e ho visto per intero le cinque stagioni di The wire e poi la miniserie su un candidato sindaco che si occupa del problema dell’assegnazione delle case popolari, Show me a hero.
Ho provato a capire da David Simon come si potesse raccontare di cose estremamente complicate e noiose – l’amministrazione cittadina, l’amministrazione municipale – come fossero la cosa più importante e figa del mondo: le politiche sociali, il sindacato, le elezioni, la scuola. Non so se avessi trovato una chiave per mettere insieme tante questioni, ma mi sembrava presumibilmente di sì. Mi sono sentito meno solo.
Christian Raimo
Christian Raimo è insegnante, saggista, scrittore. Il suo ultimo libro, in collaborazione con Alessandro Coltré, si intitola Willy. Una storia di ragazzi (Rizzoli, 2023).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati