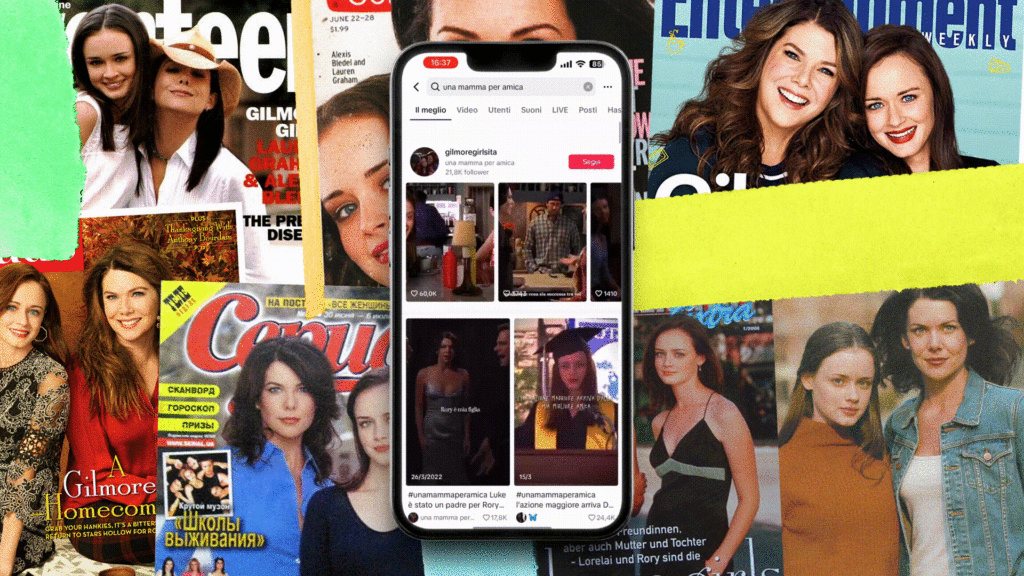Nicola H. Cosentino
“La coscienza di Zeno” non è il romanzo che ricordavi

04 Dicembre 2023
Vi diranno che “La coscienza di Zeno” è uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano. Ok, ma oltre alle sigarette e alla psicanalisi, di che parla? Nel centenario del libro, c’è chi l’ha riletto per saldare i conti con il passato liceale, scoprendone lati insospettabili e similarità con Woody Allen…
Se fosse dipeso esclusivamente da La coscienza di Zeno, oggi farei un altro mestiere. Questo perché ho sempre ricollegato Italo Svevo non soltanto alla presunta inettitudine dei suoi protagonisti, ma anche a un caso di inettitudine personale: il mio primo tentativo più o meno pubblico, e non riuscito, di fare critica letteraria.
Era il 2009, l’anno dei miei esami di Stato. Fra le tracce per il tema di italiano c’era l’analisi dell’incipit della Coscienza, in cui il dottor S., psicanalista, annuncia di aver fatto stampare le memorie di Zeno Cosini, un suo ex paziente, senza consultarlo. “Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto a dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto che egli riprenda la cura”.
Cominciai a scrivere e riempii serenamente tre facciate di foglio protocollo. Poi, all’improvviso, mi bloccai. Rilessi quanto avevo scritto e cancellai tutto. Alla fine, il tema che consegnai fu un saggio breve su Innamoramento e amore di Francesco Alberoni.
A questa ritirata seguì un tenace, pluriennale evitamento di Italo Svevo che si è concluso adesso, nel 2023, con una possibilità di riscatto imprevista: la proposta di rileggere La coscienza di Zeno e provare a riscriverne, in occasione del centenario dalla sua pubblicazione. Chi me lo ha chiesto si aspetta, a ragione, un articolo. Per me, sarà qualcos’altro: andare oltre la terza facciata del foglio protocollo del mio tema di italiano; terminarlo, con quattordici anni di ritardo.
Partiamo dall’inattendibilità della memoria. Mi ricordavo di un romanzo sulla psicanalisi, sul fumo e, appunto, sull’inettitudine. Invece, dopo averlo riletto, scopro che La coscienza di Zeno è una specie di manifesto contro la passionalità, e parla soprattutto d’amore, di salute, di reputazione. Al fumo è dedicato il capitolo più breve e frivolo del romanzo, in cui Zeno si fa isolare in una clinica e ne evade corrompendo un’infermiera. Da lì in avanti, le sigarette torneranno molto raramente, e in maniera non sempre naturale. (Sembra di vederlo, Svevo, chino sulla scrivania, che si maledice per essersi auto-vincolato a fargliele tirare fuori dal pacchetto, di tanto in tanto: “Ho scritto che fuma sempre? Ora deve fumare”). Lo stesso avviene con la psicanalisi: se ne parla solo all’inizio e alla fine, e per tutto il resto del libro (circa 300 pagine) Zeno la cita a malapena, sebbene sia la ragione per cui sta scrivendo.
Insomma, della Coscienza sono passati alla storia gli aspetti più fuorvianti e banali, guarda caso gli stessi in cui ci si imbatte leggendone il primo capitolo e parte dell’epilogo. (Dico “parte” perché il finale è un discorso a sé. Ci arriviamo fra un attimo). È un po’ come se della Divina Commedia si dicesse: “Parla di una selva e di un incontro con la Madonna”. Significa tramandare un’approssimazione: la letteratura delle infarinature e degli estratti.
C’è poi questa inettitudine, che finisce sempre per imporsi sul resto. Svevo se la trascina dietro dal 1892, anno d’uscita del suo romanzo d’esordio, che doveva intitolarsi, appunto, Un inetto, finché l’editore Ettore Vram decise di virare su Una vita. Lì, l’aspirante scrittore Alfonso Nitti abbandona il suo paese per trasferirsi a Trieste, dove trova lavoro in una banca, si innamora di Annetta – la figlia del suo capo – e stringe amicizia con il carismatico Macario. Ma rapidamente va tutto in pezzi: a un passo dallo sposare Annetta, Alfonso scappa e torna al paese; poi si pente di nuovo e rientra a Trieste, dove scopre che Annetta è ormai fidanzata con Macario. Alla fine, si suicida con le esalazioni di gas.
Qualcosa di simile accade in Senilità, del 1898, il cui protagonista Emilio Brentani perde in rapida successione l’affetto della sorella Amalia, l’amicizia dell’artista Stefano e l’amore della pur inaffidabile Angiolina (tutte le donne rilevanti, in Svevo, hanno nomi che iniziano con la A, e tutti i migliori amici fungono anche da antagonisti, e sono istrionici, popolari, un po’ stronzi).
“Insomma, della Coscienza sono passati alla storia gli aspetti più fuorvianti e banali, guarda caso gli stessi in cui ci si imbatte leggendone il primo capitolo e parte dell’epilogo. È un po’ come se della Divina Commedia si dicesse: ‘Parla di una selva e di un incontro con la Madonna’”.
Ora, sia Alfonso Nitti che Emilio Brentani si configurano, effettivamente, come degli inetti, ovvero uomini che a causa dei loro tentennamenti e dei loro timori non costruiscono niente, e perdono il poco che già possedevano. Nitti si suicida, Brentani porta al suicidio sua sorella, ed entrambi sbagliano i tempi, sbagliano i gesti, sbagliano le parole (Alfonso, di fatto, si ammazza per un fraintendimento). Ma Zeno? È davvero un inetto? Somiglia ad Alfonso ed Emilio? O forse, in qualche modo, La coscienza, scritto trentuno anni dopo Una vita e venticinque dopo Senilità, quando Svevo aveva probabilmente meno da proiettare, da temere, e più da tirare le somme, ne è il lieto fine, la pacificazione, il superamento?
A scuola – mi riferisco alla mia esperienza e a quella delle persone che conosco, magari oggi va meglio, chissà – non c’era possibilità che, parlando di Zeno, non lo si presentasse come il portabandiera del fallimento e dell’abulia. Eppure Svevo lo descrive come un uomo ricco, intelligente, colto, di larghe vedute, spiritoso, capace di suonare il violino, abilissimo a scrivere, felicemente sposato, con due figli, diverse case di proprietà e un discreto fiuto per gli affari. Pensa se non era un inetto! Considerarlo così a lungo un modello negativo, il minimo sindacale della riuscita personale, ha contribuito a distorcere il nostro concetto di “successo”, dopando le manie di grandezza di più di una generazione. Non c’è da stupirsi, quindi, se il secolo della Coscienza si chiude con i trenta-quarantenni italiani che si stringono a coorte quando Calcutta canta “sembriamo tutti falliti, tutti falliti”. Perché crediamo davvero di esserlo, e vogliamo assolverci per avere meno di quello che avevano i nostri coetanei inetti di cent’anni fa. Di più: perché è nell’aver perfezionato il loro (opinabile) fallimento che ci sentiamo ironicamente realizzati.
“In fondo, qual è l’unico ambito davvero privato? Solo il fallimento. Solo nel fallimento si può essere davvero liberi. Forse i falliti sono l’avanguardia dell’età moderna”. Lo scrive Sheila Heti, un’altra che ha fatto del tentennamento un carburante letterario. Chissà se ha mai letto Italo Svevo. Potrebbe piacerle.
A proposito di Heti. Negli ultimi anni ho letto molti bei libri le cui recensioni dicono spesso cose tipo: “odierete l’io narrante”, “vorrete scuoterlo e dirgli: svegliati!”. Io, invece, in tutti quei casi – nei libri di Heti, appunto, e di Ben Lerner, ne Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh e in Italia coi romanzi di Teresa Ciabatti, campionessa di autolesionismo – l’io narrante non lo ho odiato mai. Lo ho trovato, anzi, molto rassicurante. Questione di gusti? Può darsi. Eppure Un uomo di passaggio, La persona ideale, come dovrebbe essere? e La più amata sono libri che potremmo definire di successo, comprati, letti, apprezzati da migliaia di persone. In tanti li prendiamo in considerazione come opere che dicono qualcosa di rilevante sul presente, ma allo stesso tempo, evidentemente, sentiamo il bisogno di puntare il dito contro i protagonisti e chiosare: “Non si vive così, però”. Cioè, non ci si piange addosso, non ci si crogiola nei propri vizi, non si prova invidia.
Solo che la letteratura non è un manuale di comportamento. Cosa si legge a fare, se non per incontrare persone che si piangono addosso, si crogiolano nei propri vizi e provano invidia? Cosa vogliamo da un romanzo se non che ci faccia passare in rassegna tutta la gamma delle emozioni umane, soprattutto le più controverse, soprattutto quelle che la sera a cena non si confessano, senza giudizi, esortazioni, suggerimenti?

Zeno è servito a questo per più di cento anni. La sua missione originaria, mi sembra, era far accettare una certa tendenza all’esitazione, un certo immobilismo, in un mondo di interventisti scattanti e impulsivi. Il motivo per cui mi attraeva era che non aveva niente da insegnarmi, ma qualcosa da prestarmi: una mappa per trarre frutto, a modo mio, da ciò che consideravo disordinato o disfunzionale. Oggi che quello dello scontento è un tema nitido, ampiamente sviluppato e quasi banale, molti romanzi provano a fare lo stesso usando con generosità la parola “fallito” o il concetto di “fallimento” per lenire la diffusa percezione di non essere all’altezza delle proprie stellari aspettative.
Anche Zeno, come noi, aveva un’idea di successo esagerata, che non poteva non incrinarne l’autostima. Ed è per questo che si sente peggio di quanto non sia. È per questo che avverte l’esigenza di scardinare ogni pressione.
“Nella mente di un giovine di famiglia borghese il concetto di vita umana s’associa a quello della carriera e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore perché si può somigliare a Napoleone restando molto ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell’onda del mare, che, dacché si forma, muta ad ogni istante finché non muore! M’aspettavo perciò anch’io di divenire e disfarmi come Napoleone e l’onda”.
Quindi no, Zeno non è un inetto. Semplicemente, per sua stessa ammissione, non è Napoleone in un’epoca in cui ogni giovane uomo ambisce ancora a somigliargli. E questo non basta certo a farne un incapace. Cos’ha, davvero, che non va? Quasi niente, difetti veniali, di quelli che sfoderi su richiesta durante un colloquio di lavoro: è indolente, troppo sincero, un po’ vago nella professione e più ansioso degli altri maschi sulla scena (suo padre, suo suocero, il cognato Guido, una schiera infinita di medici: tutti tosti, impulsivi, sbrigativi), ma, appunto, meno superficiale di loro, e per questo vincente, proiettato nel futuro. “Un’avanguardia dell’età moderna”, direbbe Heti. Sta’ a vedere che è passato alla storia come inetto solo perché era attuale e si faceva delle domande!
“Il motivo per cui mi attraeva era che non aveva niente da insegnarmi, ma qualcosa da prestarmi: una mappa per trarre frutto, a modo mio, da ciò che consideravo disordinato o disfunzionale”.
Ma chi è, allora, Zeno? Di che parla davvero La coscienza? Di un uomo che, per un po’, campa di rendita, e tenta di essere una persona seria. Ha perso la madre e il fratello da ragazzino, poi il padre, ed è ossessionato dall’idea di farsi una famiglia, diventare un patriarca (cioè un’autorità riconosciuta, domestica, professionale e sociale); vuole ricevere e dare amore. Quando decide di sposarsi, si trova a scegliere fra le figlie di un suo conoscente, Giovanni Malfenti. Le sorelle si chiamano Ada, Augusta e Alberta (Anna, la quarta, è una bambina). Lui si innamora di Ada, ma viene rifiutato. Chiede allora la mano di Alberta, che rifiuta con convinzione anche maggiore. Infine, quasi scherzando, ammettendo di essere disperato, si propone ad Augusta, la meno bella, che accetta, e che il giorno delle nozze gli dirà: “Non dimenticherò mai che, pur non amandomi, mi sposasti”.
Questo dell’amore di e per Augusta Malfenti è non solo l’aspetto più complesso e affascinante del romanzo, ma anche l’unico che sia sopravvissuto incolume alle molte semplificazioni che si sono abbattute su La coscienza. L’ho ritrovato così come lo ricordavo, così come lo volevo, romantico e diplomatico insieme. Mi aveva educato a non fidarmi dell’entusiasmo, e gli devo un po’ di vecchie felicità. Zeno, di Augusta, anzi, di loro insieme, dice cose splendide, apparentemente tiepide ma in realtà brucianti, tipo: “‘Chissà se l’amo?’ È un dubbio che m’accompagnò per tutta la vita e oggidì posso pensare che l’amore accompagnato da tanto dubbio sia il vero amore”. O ancora: “La nostra fu e rimase una relazione sorridente perché io sorrisi sempre di lei, che credevo non sapesse e lei di me, a cui attribuiva molta scienza e molti errori ch’essa – così si lusingava – avrebbe corretti”.
Io sorrisi sempre di lei, e lei di me.
Un modo di intendere e concettualizzare l’amore che unisce con successo Settecento e Ottocento, romanticismo e positivismo, esaltazione e lucidità. E che rappresenta un primo segno di contatto con James Joyce, inteso sia come essere umano (raro esemplare di intellettuale innamorato di un’illetterata) sia come autore del più bel libro del Novecento. L’Ulisse, infatti, si chiude con un riferimento al matrimonio, a un amore che è promessa e compromesso: “e io che pensai beh lui ne vale un altro e poi con gli occhi gli chiesi di chiedere di nuovo sì e allora mi chiese se io volevo sì dire di sì mio fiore di montagna e prima lo abbracciai stretto sì e me lo tirai giù su di me per fargli sentire il mio seno tutto profumato sì e il suo cuore che batteva impazzito e sì dissi sì lo voglio Sì”.
Nel monologo di Molly Bloom, espressioni come “beh lui vale un altro” convivono con gli impeti di tenerezza (“me lo abbracciai stretto”, “me lo tirai giù su di me”) e i classici sintomi dell’innamoramento (il cuore di lui che batte “impazzito”). Da ragazzo cercavo ovunque questo tipo di armonia. Volevo che l’arte mi insegnasse la contraddizione, l’equilibrio fra forze distanti, e mi proteggesse dalle idealizzazioni. Inoltre, speravo di smorzare una certa tendenza insorgente al massimalismo, sviluppata per farmi ascoltare (la cosa del “più bel romanzo del Novecento”, per esempio, la dico sia di Ulisse sia di Cent’anni di solitudine, da sempre).

Per quasi tutto il liceo, fino al primo anno di università, ho amato, ricambiato, la stessa ragazza. L’ho amata abbastanza a lungo da vedere il nostro amore trasformarsi, maturare, diventare una cosa seria e reale; tanto reale che presto mi fu intollerabile qualsiasi mitizzazione, qualsiasi cliché, qualsiasi finale di Ufficiale e gentiluomo, qualsiasi bacio di Hayez, qualsiasi “Io sono Heathcliff”. Temevo che la mia storia, avviandosi a stupirmi meno che all’inizio, e non somigliando a quelle raccontate al cinema o nei libri, fosse insufficientemente potente, e immeritevole di impegno. Per questo, di contrasto, mi era utilissimo l’amore di Zeno per Augusta, che si opponeva a quella dittatura della grandiosità, dell’impeccabilità e della perenne impetuosità dei sentimenti, e che non solo tollerava i dubbi, ma ne faceva medaglie al valore. È una cosa che mi è rimasta per sempre, e in parte mi ha salvato la vita: cercare nei romanzi non un’amplificazione della gioia e della tristezza, non quello che anche da solo ero in grado di sperare e immaginare, ma ciò che si deve accettare: la prossimità di bello e brutto, noioso e divertente, ordinario e eccezionale; la bellezza come sinonimo di bilanciamento.
Nonostante l’amore per Augusta sia una sconfinata pianura – va sempre tutto bene, pure quando lui la tradisce con la cantante Carla (che d’altronde, nell’universo sveviano, è inoffensiva, avendo il nome che inizia per C e non per A) – La coscienza di Zeno è anche un romanzo di formazione. Ma di formazione della percezione di Zeno agli occhi nostri, suoi e dei suoi comprimari. Nessuno lo sospettava, perché lui stesso si è presentato come un tipo pieno di rancori, di ansie, di ipocondrie, ma nella maturità si rivela – un po’ a sorpresa – un uomo eccezionale. Glielo dice Ada, con cui il destino è stato, altrettanto a sorpresa, meno gentile. “Sono lieta per Augusta che tu sia stato tanto migliore di quanto ti credevo. […] Sei il miglior uomo della nostra famiglia, la nostra fiducia, la nostra speranza”.
I dialoghi finali fra i cognati Ada e Zeno sono fra le pagine più belle della letteratura italiana, per la tensione erotica (flirtano, o forse no, e si feriscono velatamente, o forse no, e dal nulla si sfiorano le mani), per la tristezza dell’addio (lei si trasferirà in Sudamerica) e per il senso di appagamento che suscita la vittoria del team Augusta, in partenza sfavorito.
In questo senso, La coscienza di Zeno è un libro trionfale, la festosa celebrazione dei non-fenomeni, dei falsi mediocri, un’epica dell’antiepico, l’antenato dei romanzi isterici e metropolitani della contemporaneità; non tanto un fratello di Uno, nessuno e centomila o un nipote di Le affinità elettive, quanto il patrigno di La versione di Barney, di Lamento di Portnoy, di Infinite Jest, di Sotto il vulcano. Come si può non pensare ai miti di oggi, che sono già diventati (rapidamente, tragicamente) i miti di ieri – Philip Roth, David Foster Wallace, Mordecai Richler, Malcolm Lowry, Saul Bellow, ma anche Woody Allen – leggendo quante volte compaiono, in Svevo, le parole “malattia” e “salute”? (“Inetto”, non vorrei sbagliarmi, compare zero volte). Come si può non convincersi che sia un antesignano di ogni antieroe nevrotico e ipocondriaco da strada, ufficio, bar e appartamento, quei Nathan Zuckerman e quei Barney Panofsky che fanno i reazionari e i rivoluzionari a correnti alternate, sempre a metà fra l’estasi e l’angoscia, l’eccellenza e la mediocrità, l’egoismo e la generosità? Nonché, appunto, la salute e la malattia.
Un po’ come per l’ultimo Zuckerman, che vede nelle perdite di urina la perdita di tutto il resto, per Zeno la salute va ben oltre la voglia di vivere a lungo: è il bene assoluto. E la malattia non è semplicemente una cosa che provoca dolore, ma ogni costante avversa che ci caratterizza, che segna il nostro destino: a volte un vizio, altre la curiosità, altre ancora l’egoismo. “Da molti anni io mi consideravo malato,” dice Zeno di sé “ma di una malattia che faceva soffrire piuttosto gli altri”. Quando la malattia, più raramente, è una patologia concreta, Svevo la accompagna a un altro tipo di decadimento. Il morbo di Basedow-Graves, che affligge e imbruttisce Ada, non solo la costringe a sparire dalla scena per un po’, ma converge col fallimento del suo matrimonio.
E per reagire alla malattia che Zeno comincia a scrivere (il dolore per la morte del padre, la dipendenza dal fumo); è per sopraggiunta salute che smette (gli altri sono tutti più malati di lui: evviva).
Le tre facciate scritte quattordici anni fa non tenevano in considerazione molte altre cose che oggi riconosco come significative. Su tutte la struttura: La coscienza di Zeno ha una composizione insolita, con due introduzioni, due capitoli autoconclusivi (sul fumo, sul padre), e tre storie lunghe presentate in ordine cronologico, dal momento in cui il protagonista conosce Ada a quello in cui le dice addio. Poi, un epilogo filosofico che sposta lo sguardo da dentro a fuori, dall’individuo alla collettività, dal passato al futuro; dalla coscienza di Zeno a quella degli esseri umani. Un lettore del 2023, forse, riconoscerebbe come omogenei soltanto i tre capitoli centrali, quelli in progressione, sulla storia famigliare (sebbene il terzo sia, all’inizio, abbastanza noioso). Un editor scoraggerebbe l’intero impianto.
Per lo stesso motivo, l’incipit del romanzo coinciderebbe, oggi, con la prima scena molto potente, che arriva relativamente tardi, a pagina 55, quando il padre Zeno, come ultimo gesto prima di morire, gli tira uno schiaffo. Oppure, con un’altra perla, una frase perfetta, nascosta però molto più avanti: “Non potevo stare un momento tranquillo senza invecchiare”.
Ecco, appunto: com’è invecchiato, La coscienza di Zeno, in questi cento anni? Male, direi. Ma non per colpa sua. È un capolavoro senza speranza, troppo a lungo frainteso, che rischia, da un lato, di essere noioso e incomprensibile per chiunque non sia appassionato alla letteratura e, dall’altro, di svelare la crisi dei libri di oggi, sfibrati dalla velocità, dall’assenza di mistero, dal superamento delle tensioni linguistiche (Zeno attribuisce la propria inattendibilità al fatto di dover scrivere in italiano, e quindi di dover tradurre parte dei propri pensieri dal triestino, impoverendoli), da una maggiore familiarità con la mente e con il corpo. La coscienza parla di sentimenti immortali, è vero, e a suo modo racconta un’avventura nel sapere – “chiamiamola l’avventura psichica” – a cui però, anche per colpa sua, siamo ormai assuefatti.

Eppure c’è una cosa che dovrebbe tenere aperto il discorso. Quel finale sconnesso dal resto che dialoga con il mondo contemporaneo e di cui non avevo memoria. Gli estremi sono sempre i soliti, salute-malattia. Lo riporto per intero, perché: a) mostra uno Zeno politico e quasi profetico; b) sarebbe stato una traccia ben più interessante di quella, pigrissima, sullo psicanalista vendicativo. Vale come proposta per il 2024.
“Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.
Non poteva immaginarlo, Italo Svevo, che nell’anno del centenario della sua Coscienza si sarebbe parlato tanto di questi ordigni, e della persona che, vent’anni dopo la pubblicazione del romanzo, ha effettivamente inventato un “esplosivo incomparabile”; non poteva sapere quanto avesse ragione mentre scriveva, spostando inconsapevolmente il problema da Zeno a Oppenheimer, “l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza”.
Ora, è evidente che Zeno non meriti di essere ricordato come quello del fumo e dell’inettitudine. Ma forse, a meno di non scoprire un antidoto per l’invecchiamento della cultura e per il suo travisamento, è troppo tardi. Cent’anni pesano. Qual è, però, il libro che li dimostra di più? Quello che ho studiato a scuola, di cui provai a scrivere nel 2009, o quello che ho letto con divertimento e stupore nel novembre del 2023? Quello che parla, a quanto pare, di un inetto che fuma in continuazione, o quest’altro, il pastiche di rom-com, erotismo, thriller finanziario, psicologia, teoria sociale, autobiografismo e pacifismo? La risposta non è scontata, perché il secondo esiste e il primo no. Il secondo è un romanzo meraviglioso, il primo la sinossi per colpa della quale nessuno lo legge più.
Non ho rivelato la ragione per cui, agli esami di Stato, smisi di scrivere il tema su Svevo, contribuendo, indirettamente, al suo travisamento. Lo dico adesso: mi era stato così tanto raccontato, La coscienza di Zeno, lo avevo così tanto studiato, che solo arrivato a un certo punto della stesura del mio tema, la famosa terza facciata, mi accorsi di non averlo mai davvero letto. Lo negai a me stesso, lo negai agli altri e finsi per anni, ricorrendo, se obbligato, alle formule-scappatoia (“Non lo sfoglio dal liceo…”, “Chi si ricorda, dovrei ri-leggerlo…”), come ho fatto anche qui, all’inizio di questo pezzo. Ma voglio scendere a patti con entrambe le coscienze, quella di Zeno e la mia, per confessarlo, e contribuire a indicare l’agognato antidoto all’invecchiamento e alla distorsione – che poi è, banalmente, la lettura.
Solo in questo momento sono diventato il lettore che volevo essere a diciotto anni. Solo oggi, forse, ho conseguito la maturità.
Nicola H. Cosentino
Nicola H. Cosentino è scrittore e critico letterario. Collabora con «La Lettura». Il suo ultimo romanzo è Le tracce fantasma (Minimum Fax, 2021).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati