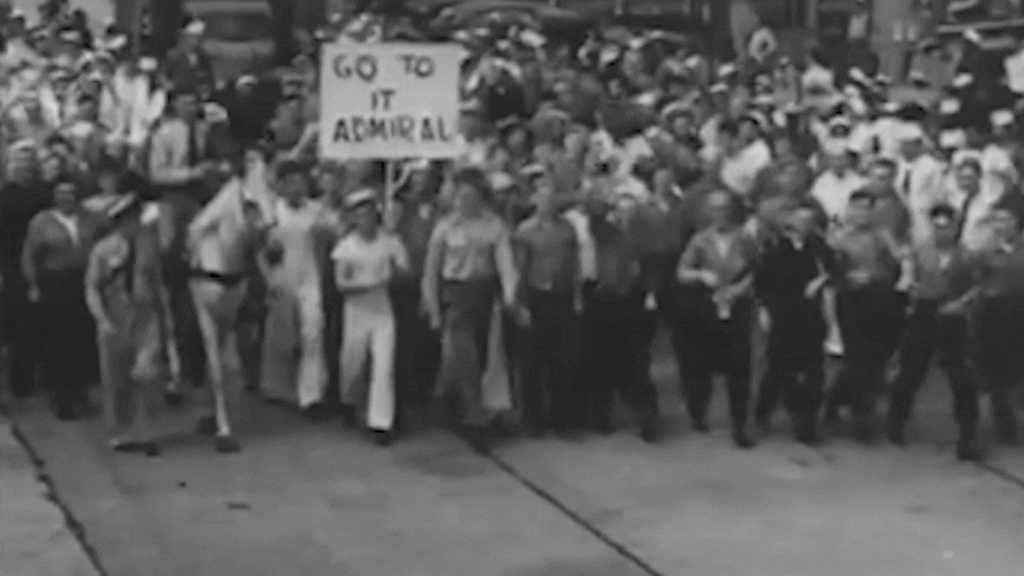Eloisa Morra
L’animale desiderante

21 Novembre 2023
Pochi autori contemporanei hanno saputo raccontare il desiderio maschile, anche incontrollabile, come Philip Roth. Forse nessuno. Questo perché, più di quanto si è soliti pensare, l'autore americano ha saputo coglierne davvero ogni aspetto – anche quelli meno in vista.
“Ti desidero”. Quante volte è capitato di sentirselo dire, o sussurrarlo a nostra volta? Quello che a freddo appare lievemente ridicolo (verbalizzare all’oggetto delle proprie brame una mancanza che lascia spaesati, ma che non è comunque un bisogno) in certe storie diviene rituale, e proprio per questo inautentico.
Chi se ne riempie la bocca — prediligendo il verbo desiderare al più spiccio volere — spesso ne è sideralmente distante, più avvezzo al gioco della seduzione che al moto continuo del Proteo dei sentimenti, muto tanto quanto la fortuna è cieca.
“Ti desidero” era uno dei motti preferiti di un uomo che aveva diversi anni più di me. Me lo ripeteva a mo’ di mantra, come se dovessi bearmi del fatto che dedicasse tempo a una persona che lo attraeva per il semplice il fatto di appartenere al vasto campione di ragazze con velleità intellettuali dotate di una dose non piccola di ingenuità.
“Più che una storia d’amore, il suo esordio racconta una disavventura dello sguardo”.
La scelta di quel termine era deliberata, volta a costruire l’immagine di un “dotto tra i libertini, libertino tra i dotti” (dunque in grado di distinguere a una prima occhiata il desiderio dall’amicizia amorosa, come se le emozioni fossero una lista vini pronta all’uso) che, se allora mi fece un po’ pena, oggi appare semplicemente fasulla, anche se ahimè sempre attuale — “Mi è capitato di desiderarti”, scrivono oggi i softboi da tastiera a chi dal vivo non oserebbero nemmeno avvicinare.
Non gli passa per la testa che desiderare significa muoversi a tentoni, come nella neve o al buio, incapaci di decifrare le tracce di una strada battuta da molti prima di noi. “Sono quello che provo o quello so, ciò che vedo o ciò a cui son cieco? Quale miopia giace non diagnosticata, non vista, non curata?”, si chiede Steven Milowitz a proposito di Neil Klugman, lo studente di filosofia protagonista dell’eponimo racconto di Goodbye Columbus.
È un personaggio verso cui si prova tenerezza, assai diverso dagli alter ego di Philip Roth maturo, ognuno a proprio modo già in grado di costruirsi una corazza che, se non costituisce certo un freno a un eros inteso come meccanismo di difesa, li mette al riparo dal desiderio.
Tra tutti — Mickey Sabbath, Nathan Zuckerman, Peter Tarnopol — il più urticante è senz’altro David Kepesh, che fa capolino per la prima volta ne Il seno (1977) e più avanti si presenta come perfetta incarnazione del narciso ad alto tasso di funzionalità che sfrutta il suo prestigio per sedurre donne in modo seriale, con un compiacimento che (a differenza di Zuckerman o Sabbath) non lascia mai spazio a ripensamenti: “Io sono un critico, sono un insegnante: la didattica è il mio destino. Deduzione o controdeduzione: è di questo che è fatta la storia. O uno impone le sue idee o se le vedrà imporre”.
Il più impietoso verso questo fare epidittico è stato David Foster Wallace, che (a sua volta accusato di averne introiettato il modello) in una recensione a Towards the End of Time di John Updike ha evidenziato i limiti della posizione fallocentrica: “Mailer, Updike, Roth — i Grandi Narcisisti Maschi che hanno dominato la narrativa realista del dopoguerra sono ormai nella loro senescenza, e a loro non deve sembrare una coincidenza che la prospettiva della loro morte appaia retroilluminata dal millennio che si avvicina e dalle previsioni online della morte del romanzo come lo conosciamo. Quando un solipsista muore, in fondo, tutto se ne va con lui.”.

Ma è davvero così autoassolutoria la narrativa di Roth? A ben vedere, la critica più puntuta a certi paradigmi ormai obsoleti arriva dalla sua stessa voce, in una battuta del Teatro di Sabbath: “Andarsene in giro con quella pancia, difendendo a spada tratta la pornografia, e tenendo alta la bandiera del cazzo. Che vecchio matto patito e fuori moda sei, Mickey Sabbath. L’ultimo guizzo polemico del maschio in croce”, gli sibila Norman, l’amico che lo ha ospitato in un momento di difficoltà ed è stato ripagato con un tentativo di seduzione della moglie e il furto delle mutandine di sua figlia Debby, di diciannove anni: “L’immensità del tuo isolamento è allucinante”.
Se desiderare si riferisce etimologicamente alla mancanza delle stelle (de-siderio), cioè di auspici augurali, allora (con buona pace di Foster Wallace) Goodbye Columbus e L’animale morente non sono che due momenti — l’aurora e il tramonto — di un analogo itinerario di avvicinamento.
L’oggetto di interesse narrativo è sempre lo stesso (che rapporto c’è tra la forza del destino individuale e le leggi che hanno dato volto all’America contemporanea?), ma diversa si è fatta via via la prospettiva d’uno scrittore che, per sua stessa ammissione, è stato “legato per tutta la vita al momento americano, sotto l’incantesimo del passato del Paese, partecipe del suo dramma e del suo destino, scrivendo nella ricca lingua madre da cui sono posseduto”.
“Non gli passa per la testa che desiderare significa muoversi a tentoni, come nella neve o al buio, incapaci di decifrare le tracce di una strada battuta da molti prima di noi”.
L’Animale morente, spesso messo in ombra dalla trilogia di Zuckerman, non è che l’estrema riflessione sulla decadenza dell’American Dream e annessa volontà di potenza. La progressiva messa in discussione dei paradigmi del maschio occidentale — e, in parallelo, delle forze che hanno prevalso nell’America del secondo Novecento — avviene mettendo in stretto dialogo diegesi e intertesti visivi.
L’ecfrasi — vale a dire la traduzione in forma verbale di un’opera d’arte visiva, reale o inventata dall’autore, all’interno di una poesia o di un romanzo — non è mai esornativa in Roth, che sin dall’inizio della sua traiettoria intellettuale, ne fa un uso parco ma incisivo.
Più che una storia d’amore, il suo esordio racconta una disavventura dello sguardo: “La prima volta che la vidi, Brenda mi chiese di tenerle gli occhiali”. L’incipit, memorabile nella sua semplicità, prefigura il fallimento futuro della relazione, dovuto alle differenze che sin da pagina uno separano i protagonisti.
Quella miope sembrerebbe Brenda Patimkin, figlia del materialismo della sua ricca famiglia wasp, ma a ben vedere il più incapace di cogliere la vera natura della realtà che gli è di fronte è proprio Neil, ebreo middle class cresciuto nell’ethos puritano che fatica a assimilarsi del tutto all’edonismo del paese d’arrivo. Parente del non ancora nato Alex Portnoy, è ancora incapace di perdere il controllo, non è dunque in grado di abbandonarsi del tutto a un desiderio autentico — accecato, più che dalla fisicità o dal carattere di Brenda, dalla serie di fantasie sulla donna prodotte da un modello di mascolinità incapace di rapportarsi a una realtà in continua evoluzione.
Che Neil osservi, ma non sia ancora in grado di vedere, lo dimostrano gli incontri con un ragazzino nero all’interno della biblioteca di Columbus. L’immagine del tredicenne dal forte accento del Sud affamato di libri d’arte è l’unica da cui si sente colpito (oltre a quella di Brenda), ma non è minimamente in grado di stabilire un contatto emotivo durante il loro scambio:
“— Ehi, mister — disse il ragazzo dopo un minuto — dov’è questo?
— Dov’è cosa?
— Dove sono queste figure? Questa gente, capo, si che è ganza. Qui non c’è nessuno che urla o che strilla, si vede bene.
Alzò il libro per farmi vedere. Era una costosa edizione di riproduzioni di Gauguin, di grande formato. La pagina che stava guardando mostrava una stampa a colori, 20×28, di tre donne indigene immerse fino alle ginocchia in un fiume rosato. Aveva ragione, era proprio un quadro silenzioso.
[…]
— Ehi, guardi, guardi questo. — Torno indietro, a una pagina dove una fanciulla con la pelle di bronzo, inginocchiata, si sporgeva in avanti come per asciugarsi i capelli. — Capo, — disse il ragazzo — questa si che è vita, cazzo.
— Chi ha fatto queste figure? — mi chiese
— Non sono figure, sono quadri. Paul Gauguin. Era un francese.
[…]
— Guardi, guardi, guardi qui, questa. Non è proprio la vita, cazzo?
Ne convenni e me ne andai”.
La leggenda dell’artista di Gauguin — divenuto già un mito grazie all’operazione di divulgazione delle “Pocket Library of Great Art” negli anni ’50 — costituisce un ironico contraltare alle scelte di vita di Neil, che non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso la morale borghese che giura di voler combattere (l’acquisto del diaframma suggerito a Brenda non ha certo intento liberatorio, come vorrebbe far credere, ma è piuttosto volto a esercitare un controllo). Tanto quanto il ragazzino non riesce a leggere nella giusta ottica Alone, cui viene alluso nell’ultimo passo, ingabbiato com’è nelle sue fantasie di supremazia erotica: in realtà, il quadro ritrae una scena di alienazione che ha valore prolettico.

Il recupero di un’adeguata prospettiva sugli eventi arriva soltanto alla fine del racconto, tra gli scaffali della Lamont Library, quando Neil — ormai solo, nel Massachusetts, separato dall’ex e lontano dalla famiglia d’origine — intravede sconsolato il suo riflesso.
A confronto, David Kepesh appare una monade. Il metodo seduttivo è ormai collaudato, complice la raggiunta maturità anagrafica (Neil è uno studente di 23 anni, David un professore di 62) e la dinamica autoassolutoria viene spesso velata da una patina di didassi — l’intero romanzo è concepito come un monologo-lezione che il protagonista tiene per uno sconosciuto interlocutore.
Niente più telefonate tartaglianti in cui si rischia la faccia, come Neil: piuttosto una festa a fine corso rivolta agli studenti del corso di “Practical Criticism”, tanto per evitare accuse di molestie sessuali da parte dell’amministrazione universitaria.
Consuela Castillo (giovane, bella, di famiglia cubana conservatrice, colta ma non troppo) parrebbe la vittima perfetta di questo modello, ma qualcosa di indefinibile arriva a sparigliare le carte. La relazione tra i due inizia quasi subito, ma non segue il copione stabilito.
Il sesso non appaga il desiderio, lo moltiplica, e dall’oggettificazione iniziale si passa a un dialogo, in seguito a… un morso, il morso che la ventiquattrenne Consuela vorrebbe dare al pene di David dopo che durante l’atto lui l’ha immobilizzata per farla sottostare alle sue fantasie: “Finalmente una reazione immediata, incisiva, primordiale da parte di quella ragazza, così classicamente bella e sempre così controllata. Fino ad allora tutto era stato dominato dal narcisismo, dall’esibizionismo, e malgrado il dispendio di energie, malgrado l’audacia, era stranamente inerte”.
“Ma è davvero così autoassolutoria la narrativa di Roth? A ben vedere, la critica più puntuta a certi paradigmi ormai obsoleti arriva dalla sua stessa voce”.
Il gioco delle reciproche maschere — il professore e la studentessa, “ragazza comune ma mai prevedibile” — cade: quel che ha inizio è un rapporto tra due singolarità complesse e indefinibili, che arrivano a scoprire cose inimmaginabili su se stesse.
Come ha spiegato Katherine Angels nel suo Il sesso che verrà, “Il nostro desiderio emerge nell’interazione; non sempre sappiamo cosa vogliamo, a volte scopriamo cose che non sapevamo di desiderare, a volte scopriamo cosa desideriamo solo nel processo. […] Il desiderio non esiste mai in isolamento. E questo è anche ciò che rende il sesso potenzialmente eccitante, ricco e significativo”.
David scopre di agognare cose che non avrebbe mai immaginato: essere dominato da Consuela, ingoiandone il sangue mestruale (illusione di dominio del desiderio stesso?); cedere alla gelosia, che non aveva mai provato prima, e poi all’inappagato che del desiderio è essenza: “Se tu l’hai, perché non puoi averla? Non riesci ad avere ciò che vuoi nemmeno quando riesci ad avere ciò che vuoi”.
L’incontro pone fine alle sue illusioni di immortalità, perché la vicinanza della giovinezza è tutt’altro che un elisir. Consuela invece, attratta (almeno all’inizio) dal prestigio, mossa dal narcisismo riflesso che comporta la conquista di un uomo maturo, scoprirà di desiderare in lui ben altro che un partner sessuale o romantico. Il dualismo dominio/sottomissione in cui Kepesh tendeva a ingabbiare i rapporti si inceppa, il paradigma del pigmalione viene progressivamente rovesciato.
“La perderò” lamenta il protagonista “io che ho acceso i suoi sensi, io che sono stato il catalizzatore della sua emancipazione”. Anche in questo caso gli inserti visivi di un romanzo più teatrale che architettonico testimoniano il cambio di passo. Nelle prime scene Consuela viene presentata attraverso il filtro del male gaze di Kepesh, che la dipinge come un’opera d’arte: se già Neil lodava “la fronte brancusiana” di Brenda, David ne paragona il fascino a immagini sempre nuove.
In prima battuta, Consuela è associata a Las Meninas di Velazquez (che inglese hanno come titolo Maids of Honor) nell’intento di mettere l’enfasi sulla sua ascendenza ispanica e benestante.
L’oggettificazione presuppone l’estrazione di alcuni dettagli biografici che vengono proiettati liberamente sul dipinto, che diviene parte della “danza dei sette veli” della seduzione: un’immagine muta, inconsapevole del proprio potere.
L’arte è usata per affascinare una ragazza che non avrebbe mai avuto accesso a quel mondo, e portare a termine la conquista; successivamente la vediamo invece sovrapposta al San Sebastiano di Mantegna (“il sangue che scende sulle cosce”), un parallelismo a prima vista blasfemo, almeno finché non si arriva alle scene finali del romanzo.

A metà racconto la bellezza destabilizzante di Consuela viene paragonata a un Picasso. Ma con la progressiva acquisizione dell’indipendenza della ragazza cambia anche la lente attraverso cui ci viene presentato il rapporto tra i due; dopo aver chiuso all’improvviso la loro relazione, sarà Consuela a ricontattare David: “Poi ricevetti una cartolina […] Fu lui che mi vietò di rispondere alla sua cartolina, cosa che morivo dalla voglia di fare, cosa che credevo di essere invitato a fare dal tronco cilindrico del busto, dall’ampiezza del bacino e dalla dolce curvatura delle cosce, dalla fiammata del pelo pubico che segna il punto dove la donna si biforca: dal tipico nudo di Modigliani, l’accessibile, lunga ragazza dei nostri sogni che lui dipingeva come per un rito e che Consuela aveva deciso di spedirmi, così impudicamente, utilizzando il servizio postale degli Stati Uniti. Un nudo i cui seni, pieni e un po’ cascanti sul lato, avrebbero potuto essere copiati dai suoi. Un nudo rappresentato a occhi chiusi, difeso, come Consuela, da nient’altro che dal suo potere erotico e, come Consuela, elementare e elegante a un tempo. Un nudo dalla pelle dorata inspiegabilmente assopito sopra un vellutato abisso nero che, nel mio stato d’animo, associavo alla tomba. Linea lunga e ondulata, lei è distesa che ti aspetta, immobile come la morte”.
Il riferimento al Reclining Nude del MOMA è funzionale a rendere visibile non solo il senso di longing (brama, desiderio: parola chiave e nucleo del romanzo, secondo Aristie Trendel) che pervade Kepesh, ancora ossessionato, ma anche il colpo di scena successivo. Una Consuela adulta ne guiderà lo sguardo nell’intento di trasmettergli un messaggio inscritto nello stretto intreccio tra Eros e Thanatos che pervade il nudo, caratterizzato da “seni, pieni e un po’ cascanti sul lato” e da un abisso nero che lo rende inquietante, associandolo all’immobilità della fine.
Poco dopo, nell’autunno del 1999, si presenterà davanti all’ex amante per mostrargli un corpo reso estraneo dalla malattia — corpo di cui gli chiederà di fotografare l’elemento fisico più presente nel monologo, il seno (continuamente descritto, evocato, rimpianto dall’amante abbandonato) prima che le venga asportato. Una metamorfosi (non solo fisica) che irrompe nel tessuto narrativo, portando a colmare in via definitiva l’asimmetria che aveva caratterizzato le mosse iniziali del rapporto.
“La relazione tra i due inizia quasi subito, ma non segue il copione stabilito. Il sesso non appaga il desiderio, lo moltiplica”.
Confrontarsi con quella che Kepesh, in un rigurgito di narcisismo, definisce la “pornografia della morte”, gli permetterà di riconsiderare la sua relazione col femminile sino a quel momento. Senza volerlo Consuela lo aiuterà ad affrontare la decadenza, mostrandosi spoglia di ogni orpello — attraverso un corpo sin troppo simile al suo, come ci rivela l’ultima significativa ecfrasi presente nel romanzo:
“C’è un quadro di Stanley Spencer appeso alla Tate, un doppio ritratto di Spencer e la moglie, nudi, in un’età tra i quaranta e i cinquant’anni. È la quintessenza della sincerità sulla coabitazione, sui due sessi che stanno insieme da chissà quanto tempo. […] Sull’orlo del tavolo, in primo piano, ci sono due pezzi di carne, un grosso cosciotto e una braciolina. La carne cruda è resa con fisiologica meticolosità, con lo stesso spietato candore dei seni cascanti e del cazzo flaccido e ciondolante raffigurati solo a qualche centimetro da quel cibo crudo”.
Leg of Mutton Nude (1937), come talvolta viene chiamato, pone sul tavolo anatomico non una costellazione di oggetti, ma un amore. L’artista Stanley Spencer lo dipinse sull’onda lunga del rimorso per aver lasciato la prima moglie per un amore divenuto in breve tempo sterile (e mai consumato), quello per Patricia Preece, il cui corpo sfatto viene posizionato in parallelo al cosciotto. E David non potrà fare a meno di associare quel nudo a Consuela: “Ogni volta che penso a Consuela vedo quel cosciotto di agnello che sembra una clava primitiva vicino ai corpi platealmente esibiti di questo marito e di questa moglie”.

Attraverso Consuela Kepesh si affratella con l’esperienza della della morte, scoprendosi per la prima volta non più maestro ma allievo: il suo senso del tempo è identico a quello della donna, che anzi lo ha sorpassato. Nell’ultima scena David pare dialogare col suo ignoto interlocutore, e prospettarne la fine imminente:
“— Devo andare. Vuole che io dorma da lei.
— Non farlo
— Cosa?
— Non andare.
— Ma devo. Qualcuno deve stare con lei.
[…]
— Pensaci. Rifletti. Perché se ci vai, sei finito”.
In molti si sono chiesti a cosa alludesse Roth con quel you’re finished: ci piace pensare che nel suo aprirsi all’imprevedibile David Kapesh abbracci finalmente se stesso.
Non si può desiderare essendo al contempo professori di desiderio: “Il desiderio costruisce e crea il reale” ricordava Erst Bloch in Spirito dell’utopia “noi soli siamo i giardinieri del misteriosissimo albero che spunterà”.
Eloisa Morra
Eloisa Morra è professoressa di Letteratura Italiana contemporanea all’Università di Toronto. Il suo ultimo lavoro si intitola: Poetiche della visibilità. Percorsi fra testo e immagine nella letteratura italiana del Novecento (Carocci, 2023).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati